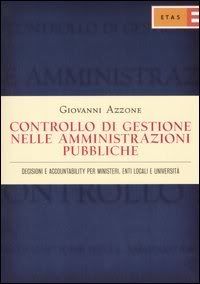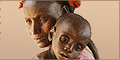La succulenta sentenza di Cassazione su Tariffa di igiene ambientale e attività amministrativa, oggi ripresa dallo Struzzo giallo, pur non essendo pioniera nell'affrontare un tema di portata serissima, mette in chiaro alcuni elementi rimasti finora, per così dire, nell'ombra. Forse perché obiettivamente disorientati da una disciplina che si stratifica di anno in anno senza mai arrestarsi, più probabilmente per volontaria refrattarietà delle amministrazioni locali a gestire questioni complesse se non vi si è in qualche modo obbligati. La questione è nota: c'era una volta il prelievo tributario più detestato dai cittadini, la Tassa rifiuti. Così iniqua nella determinazione, con i suoi bei metri quadrati indifferenti a qualsiasi coefficiente di produzione rifiuti e con le sue tariffe eterogenee, variabili da comune a comune, nonostante l'identica superficie. L'ingiustizia, in verità, era percepita più per la metronomica regolarità con la quale erano recapitate a domicilio le cartelle esattoriali che per la quantificazione del debito, anche se, ancora oggi, il lamento più gettonato è anche quello al quale è impossibile fornire una risposta plausibile: perché una famiglia di cinque persone, a parità di superficie occupata, paga come una coppia di sposi? Anche per alleviare gli addetti ai tributi comunali da questo ingrato compito, Edo Ronchi propose e fece approvare (son già dieci anni) la sua Tariffa di igiene ambientale. La quale, però, a colpi di proroghe, ancor oggi risulta facoltativa per centinaia, forse migliaia di enti. E non è possibile addurre, a proprio discarico, che la sua introduzione è troppo complicata, perché, a distanza di due lustri abbondanti, le esperienze sul campo non si contano e dunque anche la documentazione sulla quale costruire il proprio percorso regolamentare. Pare che qualcuno sostenga una motivazione miseramente elettorale per evitare il passaggio a tariffa. Vale a dire la presunta sostanziosa maggiore onerosità del nuovo sistema sarebbe da ostacolo al consenso tra gli elettori. Per quanto si possa dire male della classe politica nazionale, credo che, se questa ragione è mai stata addotta, lo è stata per un periodo molto breve e per un numero limitato di enti. Purtroppo, però, anche Ronchi è passato di moda e, per effetto del decreto ambientale della primavera 2006, ci ritroviamo in vigore ben tre sistemi distinti di tariffazione. Il primo, la TARSU, invecchiato male ma solidamente presente, il secondo, la TIA, adottato dai comuni di maggiori dimensioni senza sfondare nelle realtà minori, il terzo, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, teoricamente già in vigore dal 1° agosto, in pratica ancora in attesa dei decreti attuativi che trasferirebbero alle ATO l'intero ciclo gestionale. In attesa che qualcuno voglia davvero far luce sul quadro normativo di un prelievo così significativo, restano tutti i problemi pratici di chi ha adottato la soluzione della Tariffa Ronchi. E proprio qui interviene la Corte di Cassazione che, con una sentenza di marzo ma depositata solo poche settimane fa, statuisce che la tariffa non è un'entrata assimilabile ai corrispettivi per servizi, ma mantiene il carattere pubblicistico di tributo. Come tale, gli atti con i quali si addebitano al contribuente gli importi dovuti devono rispondere a tutti i requisiti dell'atto amministrativo tributario. Anche quando è un soggetto privato a gestire, per conto dell'ente locale, la riscossione della tariffa. Una grossa mano nel riconoscere implicitamente natura tributaria alla TIA l'aveva data il legislatore, con il D.L. n. 203/2005, che aveva attribuito al giudice tributario la competenza per dirimere le controversie sulla tariffa. A differenza di una giurisprudenza ondivaga, soprattutto nei giudizi di primo grado. La prima questione pratica derivante dalla pronuncia di agosto della Cassazione, allora, è: come deve essere compilata la fattura TIA? Teoricamente dovrebbe contenere almeno gli elementi già indicati sugli avvisi di liquidazione e accertamento con i quali si addebita la TARSU. Si tratta, a ben vedere, di un falso problema, perché la stessa Cassazione, nel 2004 e a proposito della TARSU, si era pronunciata così: "(...) anche nella cartella di pagamento il comune ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni (...) dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa." Concretamente, il modello di avviso di liquidazione utilizzato per la Tassa può essere senza troppe difficoltà e con un po' di attenzione adattato alla disciplina della Tariffa. Seconda questione pratica: la fattura TIA, in quanto atto di imposizione tributaria, deve essere notificata per renderla autonomamente impugnabile in sede di contenzioso? No, se è stata preceduta da un avviso di liquidazione costruito come indicato sopra e, appunto, notificato come si fa per la TARSU. Si, negli altri casi. Mi chiedo, però, per quale motivo un ente dovrebbe scegliere la seconda, più onerosa e cervellotica, opzione. Terza questione pratica: se la TIA è un tributo, perché devo applicare l'IVA? Su questo enigma non si è giunti a una soluzione chiarificatrice, benché la norma (L. 133/1999) abbia, con sottile sofismo, previsto l'applicazione dell'IVA dal 1° gennaio 1999 proprio sulla TIA. Almeno un paio di interpretazioni ministeriali hanno corroborato tale impostazione, ma non sono sufficienti a dissipare il dubbio, alimentato anche dalla direttiva UE n. 112/2006. Nel frattempo, che fare? Consideriamo, per analogia, il Canone per la depurazione delle acque reflue. Esso è oggetto della giurisdizione tributaria (ex art. 2, D.Lgs. n. 546/1992) e, dal 1° gennaio 1999, soggetto a IVA. Da quella data, infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31, commi 28, 29 e 30, L. 448/1998 (Finanziaria 1999), i canoni per i servizi di depurazione e fognatura non hanno più natura tributaria e, conseguentemente, sono soggetti a Iva, nella misura del 10 per cento. Il medesimo trattamento fiscale e la medesima aliquota (10%, ex n. 127-sexiesdecies, tabella A, parte III, D.P.R. 633/72) devono essere applicati anche quando questi servizi sono erogati da soggetti diversi dai Comuni (aziende speciali, società per azioni a prevalente capitale pubblico, consorzi). Possiamo azzardare dunque identico trattamento anche per la TIA, pur in un quadro apparentemente contraddittorio.
La succulenta sentenza di Cassazione su Tariffa di igiene ambientale e attività amministrativa, oggi ripresa dallo Struzzo giallo, pur non essendo pioniera nell'affrontare un tema di portata serissima, mette in chiaro alcuni elementi rimasti finora, per così dire, nell'ombra. Forse perché obiettivamente disorientati da una disciplina che si stratifica di anno in anno senza mai arrestarsi, più probabilmente per volontaria refrattarietà delle amministrazioni locali a gestire questioni complesse se non vi si è in qualche modo obbligati. La questione è nota: c'era una volta il prelievo tributario più detestato dai cittadini, la Tassa rifiuti. Così iniqua nella determinazione, con i suoi bei metri quadrati indifferenti a qualsiasi coefficiente di produzione rifiuti e con le sue tariffe eterogenee, variabili da comune a comune, nonostante l'identica superficie. L'ingiustizia, in verità, era percepita più per la metronomica regolarità con la quale erano recapitate a domicilio le cartelle esattoriali che per la quantificazione del debito, anche se, ancora oggi, il lamento più gettonato è anche quello al quale è impossibile fornire una risposta plausibile: perché una famiglia di cinque persone, a parità di superficie occupata, paga come una coppia di sposi? Anche per alleviare gli addetti ai tributi comunali da questo ingrato compito, Edo Ronchi propose e fece approvare (son già dieci anni) la sua Tariffa di igiene ambientale. La quale, però, a colpi di proroghe, ancor oggi risulta facoltativa per centinaia, forse migliaia di enti. E non è possibile addurre, a proprio discarico, che la sua introduzione è troppo complicata, perché, a distanza di due lustri abbondanti, le esperienze sul campo non si contano e dunque anche la documentazione sulla quale costruire il proprio percorso regolamentare. Pare che qualcuno sostenga una motivazione miseramente elettorale per evitare il passaggio a tariffa. Vale a dire la presunta sostanziosa maggiore onerosità del nuovo sistema sarebbe da ostacolo al consenso tra gli elettori. Per quanto si possa dire male della classe politica nazionale, credo che, se questa ragione è mai stata addotta, lo è stata per un periodo molto breve e per un numero limitato di enti. Purtroppo, però, anche Ronchi è passato di moda e, per effetto del decreto ambientale della primavera 2006, ci ritroviamo in vigore ben tre sistemi distinti di tariffazione. Il primo, la TARSU, invecchiato male ma solidamente presente, il secondo, la TIA, adottato dai comuni di maggiori dimensioni senza sfondare nelle realtà minori, il terzo, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, teoricamente già in vigore dal 1° agosto, in pratica ancora in attesa dei decreti attuativi che trasferirebbero alle ATO l'intero ciclo gestionale. In attesa che qualcuno voglia davvero far luce sul quadro normativo di un prelievo così significativo, restano tutti i problemi pratici di chi ha adottato la soluzione della Tariffa Ronchi. E proprio qui interviene la Corte di Cassazione che, con una sentenza di marzo ma depositata solo poche settimane fa, statuisce che la tariffa non è un'entrata assimilabile ai corrispettivi per servizi, ma mantiene il carattere pubblicistico di tributo. Come tale, gli atti con i quali si addebitano al contribuente gli importi dovuti devono rispondere a tutti i requisiti dell'atto amministrativo tributario. Anche quando è un soggetto privato a gestire, per conto dell'ente locale, la riscossione della tariffa. Una grossa mano nel riconoscere implicitamente natura tributaria alla TIA l'aveva data il legislatore, con il D.L. n. 203/2005, che aveva attribuito al giudice tributario la competenza per dirimere le controversie sulla tariffa. A differenza di una giurisprudenza ondivaga, soprattutto nei giudizi di primo grado. La prima questione pratica derivante dalla pronuncia di agosto della Cassazione, allora, è: come deve essere compilata la fattura TIA? Teoricamente dovrebbe contenere almeno gli elementi già indicati sugli avvisi di liquidazione e accertamento con i quali si addebita la TARSU. Si tratta, a ben vedere, di un falso problema, perché la stessa Cassazione, nel 2004 e a proposito della TARSU, si era pronunciata così: "(...) anche nella cartella di pagamento il comune ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni (...) dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa." Concretamente, il modello di avviso di liquidazione utilizzato per la Tassa può essere senza troppe difficoltà e con un po' di attenzione adattato alla disciplina della Tariffa. Seconda questione pratica: la fattura TIA, in quanto atto di imposizione tributaria, deve essere notificata per renderla autonomamente impugnabile in sede di contenzioso? No, se è stata preceduta da un avviso di liquidazione costruito come indicato sopra e, appunto, notificato come si fa per la TARSU. Si, negli altri casi. Mi chiedo, però, per quale motivo un ente dovrebbe scegliere la seconda, più onerosa e cervellotica, opzione. Terza questione pratica: se la TIA è un tributo, perché devo applicare l'IVA? Su questo enigma non si è giunti a una soluzione chiarificatrice, benché la norma (L. 133/1999) abbia, con sottile sofismo, previsto l'applicazione dell'IVA dal 1° gennaio 1999 proprio sulla TIA. Almeno un paio di interpretazioni ministeriali hanno corroborato tale impostazione, ma non sono sufficienti a dissipare il dubbio, alimentato anche dalla direttiva UE n. 112/2006. Nel frattempo, che fare? Consideriamo, per analogia, il Canone per la depurazione delle acque reflue. Esso è oggetto della giurisdizione tributaria (ex art. 2, D.Lgs. n. 546/1992) e, dal 1° gennaio 1999, soggetto a IVA. Da quella data, infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31, commi 28, 29 e 30, L. 448/1998 (Finanziaria 1999), i canoni per i servizi di depurazione e fognatura non hanno più natura tributaria e, conseguentemente, sono soggetti a Iva, nella misura del 10 per cento. Il medesimo trattamento fiscale e la medesima aliquota (10%, ex n. 127-sexiesdecies, tabella A, parte III, D.P.R. 633/72) devono essere applicati anche quando questi servizi sono erogati da soggetti diversi dai Comuni (aziende speciali, società per azioni a prevalente capitale pubblico, consorzi). Possiamo azzardare dunque identico trattamento anche per la TIA, pur in un quadro apparentemente contraddittorio.
venerdì 31 agosto 2007
Oltre il giardino
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 19:46 2 commenti
Categorie: IVA, Tariffa Ronchi, TARSU
giovedì 30 agosto 2007
Un colpo al cerchio
 Chissà a cosa serve davvero istituire un ufficio di staff alle dirette dipendenze del capo dell'amministrazione (Sindaco o Presidente che sia)? Nella più tipica tradizione trasformistica italiana, un funzionario già dipendente di un ente locale (e dunque ad esso legato da un vincolo di professionalità imparziale) può essere nominato dal Sindaco o dal Presidente "per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge", come prevede l'art. 90 del TUEL. In quella locuzione non proprio esplicita può essere compreso tutto e il suo contrario ma, senza alcun dubbio, la prevalente opinione degli addetti ai lavori è che lavorare per il Sindaco nell'esercizio di quelle funzioni significhi soprattutto fargli: a) da portaborse; b) da ufficio stampa; c) da segretario personale (non necessariamente in quest'ordine). A qualche amministratore compiaciuto non par vero sapere di essere autorizzato a istituire una struttura di collaboratori (anche uno solo, al limite) che a lui solo riferisce, una sorta di ente parallelo, slegato dagli ordinari vincoli che imporrebbero un filtro politico e gestionale (dal Consiglio ai dirigenti) ben strutturato. Per coprire questa posizione (regolarmente inserita nell'organico dell'ente) il legislatore ha appunto previsto una sorta di esclusività delle opzioni di scelta a disposizione dell'amministratore nominante: il prescelto non potrà che essere un dipendente già in forza alla struttura amministrativa, destinato, per la durata del mandato elettivo, a nuovi e più alti compiti. Oppure, è offerta la possibilità di indire un'apposita procedura concorsuale che però non può garantire al neo-assunto un impiego duraturo: al massimo, fino alle prossime elezioni (salvo riconferma della stessa maggioranza). Quella norma, infatti, è stata sì interpretata come una specificazione del genus previsto dall'art. 110 TUEL, ma con una limitazione oggettiva che privilegia la soluzione interna. Ma perché limitarsi a guardare nel proprio orticello, quando il libero mercato offre fior di candidati. A questo proposito, in più occasioni, la Corte dei conti ha sanzionato quegli amministratori che hanno scelto di farsi affiancare nella loro attività da soggetti assunti ex art. 90 (da ultimo, la sezione pugliese con sentenza n. 241/2007, ma in precedenza anche la sezione della Toscana con decisione n. 624/2004) in maniera non ortodossa, cioè utilizzando le procedure più spiccie dell'affidamento diretto intuitu personae ex art. 110 TUEL. Che però riguarda in via generale gli incarichi di alta specializzazione extra dotazione organica e non potrebbe essere automaticamente applicato a una fattispecie altrimenti regolata. Ovviamente, il punto critico per la magistratura contabile è rappresentato soprattutto dalla disinvoltura con la quale si retribuiscono questi incarichi rispetto al formale rispetto dei CCNL previsto obbligatoriamente dall'art. 90 TUEL. Sotto questo profilo, come dare torto alle pronunce della Corte? In assenza di vincoli specifici, può passare qualsiasi nefandezza e l'assistente del Sindaco può essere retribuito con un trattamento pari a quello di un dipendente di categoria D3 pur non avendo il diploma di laurea (è il caso della sentenza pugliese), ma soprattutto pur non avendo alcuna esperienza precedente all'interno di un ente pubblico. In realtà, vorrei ribaltare la prospettiva del ragionamento. Per svolgere i compiti di staff di cui si parla, comunque non assimilabili a quelli di un funzionario con responsabilità di gestione e risultato, non potrebbe bastare il diploma di scuola media superiore e l'attribuzione di una categoria non superiore alla C (quella degli istruttori amministrativi, per intenderci)? E dunque, se un Sindaco decidesse di incaricare direttamente un diplomato retribuendolo da diplomato, non sarebbe forse meno ipocrita di uno che, per l'identica posizione, sceglie di bandire un concorso ma di categoria D3?
Chissà a cosa serve davvero istituire un ufficio di staff alle dirette dipendenze del capo dell'amministrazione (Sindaco o Presidente che sia)? Nella più tipica tradizione trasformistica italiana, un funzionario già dipendente di un ente locale (e dunque ad esso legato da un vincolo di professionalità imparziale) può essere nominato dal Sindaco o dal Presidente "per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge", come prevede l'art. 90 del TUEL. In quella locuzione non proprio esplicita può essere compreso tutto e il suo contrario ma, senza alcun dubbio, la prevalente opinione degli addetti ai lavori è che lavorare per il Sindaco nell'esercizio di quelle funzioni significhi soprattutto fargli: a) da portaborse; b) da ufficio stampa; c) da segretario personale (non necessariamente in quest'ordine). A qualche amministratore compiaciuto non par vero sapere di essere autorizzato a istituire una struttura di collaboratori (anche uno solo, al limite) che a lui solo riferisce, una sorta di ente parallelo, slegato dagli ordinari vincoli che imporrebbero un filtro politico e gestionale (dal Consiglio ai dirigenti) ben strutturato. Per coprire questa posizione (regolarmente inserita nell'organico dell'ente) il legislatore ha appunto previsto una sorta di esclusività delle opzioni di scelta a disposizione dell'amministratore nominante: il prescelto non potrà che essere un dipendente già in forza alla struttura amministrativa, destinato, per la durata del mandato elettivo, a nuovi e più alti compiti. Oppure, è offerta la possibilità di indire un'apposita procedura concorsuale che però non può garantire al neo-assunto un impiego duraturo: al massimo, fino alle prossime elezioni (salvo riconferma della stessa maggioranza). Quella norma, infatti, è stata sì interpretata come una specificazione del genus previsto dall'art. 110 TUEL, ma con una limitazione oggettiva che privilegia la soluzione interna. Ma perché limitarsi a guardare nel proprio orticello, quando il libero mercato offre fior di candidati. A questo proposito, in più occasioni, la Corte dei conti ha sanzionato quegli amministratori che hanno scelto di farsi affiancare nella loro attività da soggetti assunti ex art. 90 (da ultimo, la sezione pugliese con sentenza n. 241/2007, ma in precedenza anche la sezione della Toscana con decisione n. 624/2004) in maniera non ortodossa, cioè utilizzando le procedure più spiccie dell'affidamento diretto intuitu personae ex art. 110 TUEL. Che però riguarda in via generale gli incarichi di alta specializzazione extra dotazione organica e non potrebbe essere automaticamente applicato a una fattispecie altrimenti regolata. Ovviamente, il punto critico per la magistratura contabile è rappresentato soprattutto dalla disinvoltura con la quale si retribuiscono questi incarichi rispetto al formale rispetto dei CCNL previsto obbligatoriamente dall'art. 90 TUEL. Sotto questo profilo, come dare torto alle pronunce della Corte? In assenza di vincoli specifici, può passare qualsiasi nefandezza e l'assistente del Sindaco può essere retribuito con un trattamento pari a quello di un dipendente di categoria D3 pur non avendo il diploma di laurea (è il caso della sentenza pugliese), ma soprattutto pur non avendo alcuna esperienza precedente all'interno di un ente pubblico. In realtà, vorrei ribaltare la prospettiva del ragionamento. Per svolgere i compiti di staff di cui si parla, comunque non assimilabili a quelli di un funzionario con responsabilità di gestione e risultato, non potrebbe bastare il diploma di scuola media superiore e l'attribuzione di una categoria non superiore alla C (quella degli istruttori amministrativi, per intenderci)? E dunque, se un Sindaco decidesse di incaricare direttamente un diplomato retribuendolo da diplomato, non sarebbe forse meno ipocrita di uno che, per l'identica posizione, sceglie di bandire un concorso ma di categoria D3?
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 18:14 0 commenti
mercoledì 29 agosto 2007
I dinamitardi
 La stampa vive di esagerazioni, da sempre. Per vendere più copie cartacee, una volta. Per aumentare gli accessi web, oggi. Se poi c'è da proporre una rettifica, si trova sempre tempo e spazio a disposizione, ma per attirare l'attenzione serve un fuoco d'artificio. Mica per niente lo chiamano quarto potere. Memori della lezione di John Ford, secondo il quale quando la leggenda si fa realtà, è sempre la prima a dover essere stampata, quelli della Cgia di Mestre ci riprovano. Ecco dunque la clamorosa bomba da prima pagina: "Fisco, boom delle tasse locali: aumento dell'111% - Siamo di fronte al boom delle tasse locali. L'allarme arriva dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre che ha dimostrato come dal 1995 al 2006, le entrate fiscali degli enti locali sono passate da 37.699,04 milioni di euro a 95.911 milioni di euro: un aumento in percentuale del 111%. L'amministrazione centrale, invece, ha incrementato le entrate del 12,1%." L'incremento in questione va calcolato a euro costanti, cioè depurato dall'inflazione nel frattempo verificatasi. Resta la tremenda realtà di questo triplo uno sbattuto in prima pagina a beneficio del censore di turno. Ci stiamo un po' stufando di questa faciloneria ipocrita che raccoglie i dati a disposizione, li frulla per pochi secondi senza zucchero e ne estrae un beverone adatto solo agli stomaci meno delicati, le bocche buone dell’informazione un tanto a parola. Il nervosismo cresce in proporzione alla scarsità, in questa come in mille altre indagini analoghe, di analisi, o meglio, alla chiara intenzione di offrire un'interpretazione mirata della realtà, ignorando alcuni dati e utilizzandone altri, funzionali alla tesi esposta. Quando il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi, afferma che durante gli "ultimi anni soprattutto i Comuni hanno assunto un gran numero di nuove competenze e di nuove funzioni, senza ricevere in cambio un corrispondente aumento dei trasferimenti. Anzi. La situazione dei nostri conti pubblici ha costretto lo Stato centrale a ridurli progressivamente creando non pochi problemi di bilancio a tante piccole realtà amministrative locali che si sono 'difese' aumentando le imposte locali", dice una mezza verità. Correttamente, si premette che l’attività dei Comuni si è ampliata negli anni e che la rideterminazione dei trasferimenti erariali si è verificata al ribasso, centellinando i tagli ma operandoli costantemente, erodendo una base di risorse certe sulla quale gli enti facevano conto per far quadrare l’equilibrio di parte corrente. La conseguenza è stata la progressiva tendenza a compensare con tributi propri ciò che non arrivava dal centro. Arrivati a questo punto, però, si dovrebbe fornire ai propri lettori un chiarimento chiave. Che Bortolussi ne sia consapevole oppure no (se non lo fosse, a preoccuparsi dovrebbero essere soprattutto gli imprenditori associati alla Cgia), nella definizione operativa vigente di ‘tributi locali’ rientra la quota di compartecipazione all'IRPEF assegnata ai Comuni dallo Stato, benché erogata come fosse un trasferimento corrente qualsiasi. Poiché, inoltre, l'accento è marcato sulla differenza tra questo incremento e quello corrispondente a livello statale, val la pena sottolineare che proprio questa entrata appare contemporaneamente nei bilanci nazionali e locali, ma è propria solo dei primi. Si tratta di un'entrata sulla quale non abbiamo la benché minima discrezionalità di manovra e la cui entità ci viene comunicata insieme agli altri trasferimenti dello Stato. Visto che si discute di somme che da sole rappresentano tra il 30 e il 40 per cento degli accertamenti del titolo I, vien facile ridimensionare il timor panico della Cgia e discutere più serenamente del peso della fiscalità locale, del quale nessuno intende disconoscere la recrudescenza negli ultimi anni. Anche perché ai mestrini gli argomenti non mancano. Da un lato, si richiama l’uso non necessariamente ortodosso fatto delle risorse tributarie, con ridotta o poco qualificata erogazione di servizi. Dall’altro, si fa leva sul federalismo fiscale per sostenere che i Comuni dovrebbero avere più autonomia nella gestione delle risorse di propria competenza. Temi seri ai quali farebbe bene una dose più accurata di onestà intellettuale.
La stampa vive di esagerazioni, da sempre. Per vendere più copie cartacee, una volta. Per aumentare gli accessi web, oggi. Se poi c'è da proporre una rettifica, si trova sempre tempo e spazio a disposizione, ma per attirare l'attenzione serve un fuoco d'artificio. Mica per niente lo chiamano quarto potere. Memori della lezione di John Ford, secondo il quale quando la leggenda si fa realtà, è sempre la prima a dover essere stampata, quelli della Cgia di Mestre ci riprovano. Ecco dunque la clamorosa bomba da prima pagina: "Fisco, boom delle tasse locali: aumento dell'111% - Siamo di fronte al boom delle tasse locali. L'allarme arriva dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre che ha dimostrato come dal 1995 al 2006, le entrate fiscali degli enti locali sono passate da 37.699,04 milioni di euro a 95.911 milioni di euro: un aumento in percentuale del 111%. L'amministrazione centrale, invece, ha incrementato le entrate del 12,1%." L'incremento in questione va calcolato a euro costanti, cioè depurato dall'inflazione nel frattempo verificatasi. Resta la tremenda realtà di questo triplo uno sbattuto in prima pagina a beneficio del censore di turno. Ci stiamo un po' stufando di questa faciloneria ipocrita che raccoglie i dati a disposizione, li frulla per pochi secondi senza zucchero e ne estrae un beverone adatto solo agli stomaci meno delicati, le bocche buone dell’informazione un tanto a parola. Il nervosismo cresce in proporzione alla scarsità, in questa come in mille altre indagini analoghe, di analisi, o meglio, alla chiara intenzione di offrire un'interpretazione mirata della realtà, ignorando alcuni dati e utilizzandone altri, funzionali alla tesi esposta. Quando il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi, afferma che durante gli "ultimi anni soprattutto i Comuni hanno assunto un gran numero di nuove competenze e di nuove funzioni, senza ricevere in cambio un corrispondente aumento dei trasferimenti. Anzi. La situazione dei nostri conti pubblici ha costretto lo Stato centrale a ridurli progressivamente creando non pochi problemi di bilancio a tante piccole realtà amministrative locali che si sono 'difese' aumentando le imposte locali", dice una mezza verità. Correttamente, si premette che l’attività dei Comuni si è ampliata negli anni e che la rideterminazione dei trasferimenti erariali si è verificata al ribasso, centellinando i tagli ma operandoli costantemente, erodendo una base di risorse certe sulla quale gli enti facevano conto per far quadrare l’equilibrio di parte corrente. La conseguenza è stata la progressiva tendenza a compensare con tributi propri ciò che non arrivava dal centro. Arrivati a questo punto, però, si dovrebbe fornire ai propri lettori un chiarimento chiave. Che Bortolussi ne sia consapevole oppure no (se non lo fosse, a preoccuparsi dovrebbero essere soprattutto gli imprenditori associati alla Cgia), nella definizione operativa vigente di ‘tributi locali’ rientra la quota di compartecipazione all'IRPEF assegnata ai Comuni dallo Stato, benché erogata come fosse un trasferimento corrente qualsiasi. Poiché, inoltre, l'accento è marcato sulla differenza tra questo incremento e quello corrispondente a livello statale, val la pena sottolineare che proprio questa entrata appare contemporaneamente nei bilanci nazionali e locali, ma è propria solo dei primi. Si tratta di un'entrata sulla quale non abbiamo la benché minima discrezionalità di manovra e la cui entità ci viene comunicata insieme agli altri trasferimenti dello Stato. Visto che si discute di somme che da sole rappresentano tra il 30 e il 40 per cento degli accertamenti del titolo I, vien facile ridimensionare il timor panico della Cgia e discutere più serenamente del peso della fiscalità locale, del quale nessuno intende disconoscere la recrudescenza negli ultimi anni. Anche perché ai mestrini gli argomenti non mancano. Da un lato, si richiama l’uso non necessariamente ortodosso fatto delle risorse tributarie, con ridotta o poco qualificata erogazione di servizi. Dall’altro, si fa leva sul federalismo fiscale per sostenere che i Comuni dovrebbero avere più autonomia nella gestione delle risorse di propria competenza. Temi seri ai quali farebbe bene una dose più accurata di onestà intellettuale.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 19:31 0 commenti
Categorie: Federalismo fiscale, Fiscalità locale
martedì 28 agosto 2007
Specchio dei tempi
 In tema di spesa pubblica, stiamo raccogliendo da mesi una sterminata bibliografia che, normalmente, insiste sulla leggendaria tendenza allo sperpero di risorse perpetrato da gran parte delle amministrazioni. Il confronto con la realtà dell'impresa privata è spesso impietoso, soprattutto se il termine di paragone è rappresentato dalle amministrazioni centrali, ministeri in testa. Poiché però anche gli enti locali sono frequentemente accusati di partecipare allo scempio, nel calderone indistinguibile c'è davvero spazio per tutti e basta la parola 'spesa' accoppiata con qualcosa che abbia a che fare con il settore pubblico e, immediatamente, sono sguinzagliati cani inferociti a caccia di nuovi sprechi. Che abbiano ragione o no, non fa alcuna differenza perché ormai l'associazione di idee che ciascuno fa, e alla quale siamo malinconicamente abituati, è quella tra 'settore pubblico' e 'inefficienza'. Stanchi di sentir fischiettare la stessa solfa, ci aspettiamo di quando in quando un intervento che eviti di ricalcare orme invecchiate e spinga il ragionamento un po' più in su, per selezionare le cose eventualmente da fare. Invece, si insiste a riempire colonne di piombo con materiali stantii. Torno di nuovo a bacchettare il Lenzuolo rosa perché se lo merita. Qual è, infatti, il senso di un pezzo come quello pubblicato a pagina 47 nell'edizione di ieri? Dietro il titolo tonitruante "I Comuni tornano a spendere" si nasconde, infatti, mascherato da scoop estivo, un elenco risaputo di concetti; si, insomma, una non notizia. Il tono didascalico con il quale ci vengono spiegati i contenuti del certificato al bilancio di previsione fa pensare che l'articolo sia stato commissionato per un pubblico di lettori che con gli enti locali non hanno alcun rapporto e che proseguono nella lettura affascinati dal mistero del 'welfare allargato' "al centro delle discussioni delle organizzazioni sindacali in tema di bilancio" o ancora ammaliati dal miraggio delle spese correnti "quelle classificate al titolo I del bilancio unite alle spese per il rimborso del debito al titolo III della spesa." Tutti gli altri, che si sono fiondati alle ultime pagine del dorso del lunedì, intitolato, guarda un po', 'Autonomie locali e PA', perché assetati di novità e idee, devono accontentarsi di perle quali: "Il nostro ordinamento (...) assegna al Municipio funzioni proprie e funzioni conferite (con leggi statali e regionali) (...)" oppure "In vetta alla classifica, stilata sulla base del volume di spesa, vi è il settore dei servizi alla persona e alla comunità". E se a qualche furbacchione in vena di ribattere colpo su colpo venisse in mente di affermare che le pagine dedicate agli enti locali possono ben essere lette da professionisti del tutto all'oscuro dei meccanismi della finanza pubblica, sarebbe fin troppo facile ricordare che, ogni santo giorno, si leggono nel dorso Finanza & Mercati paginate ricche della terminologia più specialistica che si possa desiderare, pressoché illeggibili a chi non abbia una laurea a Princeton, senza che il quotidiano si senta in dovere di spiegare cosa significa cosa. Lo spazio messo a disposizione dal quotidiano, però, è sufficiente per affiancare al pezzo principale un articolo di spalla che ci riporta a una dimensione meno scontata: l'invecchiamento della contabilità comunale in un mondo di esternalizzazioni diffuse. Il tema si snocciola su un percorso logico che partendo dalla presenza ormai desueta, ad esempio, delle centrali del latte tra i servizi comunali vorrebbe dimostrare la scarsa capacità informativa dei documenti ufficiali di bilancio, impediti così a rappresentare la realtà complessa delle società partecipate, assenti dalle partite in entrata e uscita. Si caldeggia l'introduzione rapida del bilancio consolidato per recuperare trasparenza e accountability. Che è come mischiare pere e mele, perché le società di capitali, benché a partecipazione pubblica più o meno intensa, agiscono in un mercato dove si seguono le regole della profittabilità, anche se con finalità di reinvestimento, e per le quali i concetti di costo e ricavo non possono essere associati con semplice automatismo all'attività pubblica. Voglio dire, cioè, che se il Comune non fornisce più determinati servizi, la spesa per essi sostenuta da soggetti partecipati privati dovrebbe essere imputata solo a questi ultimi, perché determinata con criteri esclusivamente economici che non tengono più conto della specificità territoriale. E questo sarà vero anche quando, in un momento si spera non troppo distante, la contabilità economica apparirà basilare anche nei comuni. Questo sì che è un punto cardinale, dove dovrebbe puntare costantemente l'ago della bussola di studiosi e specialisti.
In tema di spesa pubblica, stiamo raccogliendo da mesi una sterminata bibliografia che, normalmente, insiste sulla leggendaria tendenza allo sperpero di risorse perpetrato da gran parte delle amministrazioni. Il confronto con la realtà dell'impresa privata è spesso impietoso, soprattutto se il termine di paragone è rappresentato dalle amministrazioni centrali, ministeri in testa. Poiché però anche gli enti locali sono frequentemente accusati di partecipare allo scempio, nel calderone indistinguibile c'è davvero spazio per tutti e basta la parola 'spesa' accoppiata con qualcosa che abbia a che fare con il settore pubblico e, immediatamente, sono sguinzagliati cani inferociti a caccia di nuovi sprechi. Che abbiano ragione o no, non fa alcuna differenza perché ormai l'associazione di idee che ciascuno fa, e alla quale siamo malinconicamente abituati, è quella tra 'settore pubblico' e 'inefficienza'. Stanchi di sentir fischiettare la stessa solfa, ci aspettiamo di quando in quando un intervento che eviti di ricalcare orme invecchiate e spinga il ragionamento un po' più in su, per selezionare le cose eventualmente da fare. Invece, si insiste a riempire colonne di piombo con materiali stantii. Torno di nuovo a bacchettare il Lenzuolo rosa perché se lo merita. Qual è, infatti, il senso di un pezzo come quello pubblicato a pagina 47 nell'edizione di ieri? Dietro il titolo tonitruante "I Comuni tornano a spendere" si nasconde, infatti, mascherato da scoop estivo, un elenco risaputo di concetti; si, insomma, una non notizia. Il tono didascalico con il quale ci vengono spiegati i contenuti del certificato al bilancio di previsione fa pensare che l'articolo sia stato commissionato per un pubblico di lettori che con gli enti locali non hanno alcun rapporto e che proseguono nella lettura affascinati dal mistero del 'welfare allargato' "al centro delle discussioni delle organizzazioni sindacali in tema di bilancio" o ancora ammaliati dal miraggio delle spese correnti "quelle classificate al titolo I del bilancio unite alle spese per il rimborso del debito al titolo III della spesa." Tutti gli altri, che si sono fiondati alle ultime pagine del dorso del lunedì, intitolato, guarda un po', 'Autonomie locali e PA', perché assetati di novità e idee, devono accontentarsi di perle quali: "Il nostro ordinamento (...) assegna al Municipio funzioni proprie e funzioni conferite (con leggi statali e regionali) (...)" oppure "In vetta alla classifica, stilata sulla base del volume di spesa, vi è il settore dei servizi alla persona e alla comunità". E se a qualche furbacchione in vena di ribattere colpo su colpo venisse in mente di affermare che le pagine dedicate agli enti locali possono ben essere lette da professionisti del tutto all'oscuro dei meccanismi della finanza pubblica, sarebbe fin troppo facile ricordare che, ogni santo giorno, si leggono nel dorso Finanza & Mercati paginate ricche della terminologia più specialistica che si possa desiderare, pressoché illeggibili a chi non abbia una laurea a Princeton, senza che il quotidiano si senta in dovere di spiegare cosa significa cosa. Lo spazio messo a disposizione dal quotidiano, però, è sufficiente per affiancare al pezzo principale un articolo di spalla che ci riporta a una dimensione meno scontata: l'invecchiamento della contabilità comunale in un mondo di esternalizzazioni diffuse. Il tema si snocciola su un percorso logico che partendo dalla presenza ormai desueta, ad esempio, delle centrali del latte tra i servizi comunali vorrebbe dimostrare la scarsa capacità informativa dei documenti ufficiali di bilancio, impediti così a rappresentare la realtà complessa delle società partecipate, assenti dalle partite in entrata e uscita. Si caldeggia l'introduzione rapida del bilancio consolidato per recuperare trasparenza e accountability. Che è come mischiare pere e mele, perché le società di capitali, benché a partecipazione pubblica più o meno intensa, agiscono in un mercato dove si seguono le regole della profittabilità, anche se con finalità di reinvestimento, e per le quali i concetti di costo e ricavo non possono essere associati con semplice automatismo all'attività pubblica. Voglio dire, cioè, che se il Comune non fornisce più determinati servizi, la spesa per essi sostenuta da soggetti partecipati privati dovrebbe essere imputata solo a questi ultimi, perché determinata con criteri esclusivamente economici che non tengono più conto della specificità territoriale. E questo sarà vero anche quando, in un momento si spera non troppo distante, la contabilità economica apparirà basilare anche nei comuni. Questo sì che è un punto cardinale, dove dovrebbe puntare costantemente l'ago della bussola di studiosi e specialisti.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 20:58 0 commenti
Categorie: Bilancio consolidato, Certificato al bilancio di previsione, Contabilità finanziaria
lunedì 27 agosto 2007
Sedie a sdraio
 Il dibattito innescato dal Lenzuolo rosa sulla scarsa efficacia dei nuclei di valutazione a misurare la qualità delle prestazioni dirigenziali sta un po' scappando di mano a chi lo ha promosso. Sul numero di oggi, infatti, appare un intervento a cura del presidente della Fondazione PromoPA, Gaetano Scognamiglio, che apre un filone di indagine di tutt'altra natura, assumendo come cardine essenziale il ruolo del Consiglio dell'ente. Nelle precedenti puntate, chi era intervenuto aveva sottolineato le carenze più culturali che legislative di un sistema ancora bloccato dal vizio capitale delle pubbliche amministrazioni: la paura quasi ancestrale del cambiamento. E si sottolineava come, pur in presenza di un corpo di norme adeguate (un discorso interamente differente riguarda il sistema contabile), la pratica amministrativa non fa (non vuole fare) quello scatto decisivo che, ad esempio, sarebbe rappresentato da una programmazione dettagliata fatta di obiettivi chiari e oggettivamente quantificabili. Nell'attuale catena di comando, ciò dovrebbe verificarsi a livello di PEG, di competenza cioè giuntale, essendo affidato alle assemblee consiliari il compito di programmazione generale contenuto nei documenti di bilancio annuali e pluriennali, dal profilo interamente strategico. Gaetano Scognamiglio, dal suo canto, non si lascia sfuggire l'assist e va in rete con un argomento semplice semplice: laddove gli organi esecutivi hanno sostanzialmente fallito (perché i controlli interni sono come colabrodo che non trattengono alcuno spreco) possono con più incisività riuscire i Consigli, se solo gli si consentisse di operare compiutamente. La teoria dell'autore è che le assemblee consiliari sono di fatto esautorate dall'attività di controllo, perché, ad esempio (ma si tratta dell'esempio per definizione), il bilancio si approva senza che le minoranze possano incidere davvero sui suoi contenuti, ma soprattutto perché l'apparato burocratico interno non considera i consiglieri come interlocutori principali, fornendo loro una documentazione poco chiara o comunque incompleta. Quest'ultima accusa mi sembra davvero gratuita. Chi fa i salti mortali per consegnare all'intera assemblea nei tempi rigorosi richiesti dalla legge tutto il materiale necessario per discutere nella sessione di bilancio sa bene che nelle settimane successive (più che sufficienti a entrare nel merito dei contenuti) sono ben poche (quando ci sono) le richieste di delucidazione che giungono all'ufficio finanziario. Scognamiglio parla di "debolezza degli uffici di supporto, che spesso rischiano di essere una segreteria che smista semplicemente le pratiche nelle commissioni e redige gli ordini del giorno", ma quante volte i gruppi di minoranza presentano (per scarsa voglia o per supponenza, importa poco) emendamenti irricevibili senza neppure aver chiesto all'ufficio un parere sulla forma più adeguata di presentazione? Vien voglia qui di ribaltare il pregiudizio: le minoranze ritengono che gli uffici comunali siano al servizio esclusivo della maggioranza e ne stanno alla larga per timore di non ricevere risposte trasparenti. La consapevolezza che l'intero set di strumenti di programmazione, così come voluti dal legislatore, sia in gran parte inaccessibile al neofita non può giustificare la perenne indolenza di chi siede in consiglio (anche tra i banchi della maggioranza) a voler comprendere (e non parlo di approfondire) concetti elementari ma fondamentali come: equilibrio di parte corrente, indici di indebitamento, avanzo di amministrazione, residui attivi e passivi, impegni e accertamenti, ecc. Ne risulta, è ovvio, un'incapacità a controllare che non ha quasi nulla a che vedere con l'isolamento paventato nell'articolo. Quanto ai rimedi per ovviare allo squilibrio di cui si lamenta, ve n'è uno che pare messo lì apposta per ingenerar polemiche. Si richiede, infatti, "formazione specifica per tutti i funzionari che sono addetti a qualsiasi titolo a supportare le attività delle commissioni, dei gruppi e della presidenza." Parrebbe, cioè, che a capo degli uffici comunali (segreteria, ragioneria, tecnico...) vi sia una classe di dirigenti (se non di diritto, almeno di fatto) mediamente impreparata, alla quale servono corsi, non di aggiornamento, ma di formazione per coadiuvare gli amministratori. In quale mondo vive Scognamiglio? Un mondo dove è necessario trasformare "gli attuali uffici di segreteria in uffici di programmazione e controllo (?), riequilibrando con l'esecutivo l'utilizzo delle collaborazioni di supporto (??)". Un mondo dove la confusione regna sovrana, piuttosto. Perché la vera chiave per risolvere l'enigma sta, come è stato già scritto, nella chiarezza di idee di chi programma. Se un salto di qualità va fatto, non si ribalti il problema accusando l'apparato di scarsa collaborazione. Si abbia invece il coraggio di rimettersi in discussione e fornire un ricambio culturale prima ancora che generazionale a chi si candida ad amministrare.
Il dibattito innescato dal Lenzuolo rosa sulla scarsa efficacia dei nuclei di valutazione a misurare la qualità delle prestazioni dirigenziali sta un po' scappando di mano a chi lo ha promosso. Sul numero di oggi, infatti, appare un intervento a cura del presidente della Fondazione PromoPA, Gaetano Scognamiglio, che apre un filone di indagine di tutt'altra natura, assumendo come cardine essenziale il ruolo del Consiglio dell'ente. Nelle precedenti puntate, chi era intervenuto aveva sottolineato le carenze più culturali che legislative di un sistema ancora bloccato dal vizio capitale delle pubbliche amministrazioni: la paura quasi ancestrale del cambiamento. E si sottolineava come, pur in presenza di un corpo di norme adeguate (un discorso interamente differente riguarda il sistema contabile), la pratica amministrativa non fa (non vuole fare) quello scatto decisivo che, ad esempio, sarebbe rappresentato da una programmazione dettagliata fatta di obiettivi chiari e oggettivamente quantificabili. Nell'attuale catena di comando, ciò dovrebbe verificarsi a livello di PEG, di competenza cioè giuntale, essendo affidato alle assemblee consiliari il compito di programmazione generale contenuto nei documenti di bilancio annuali e pluriennali, dal profilo interamente strategico. Gaetano Scognamiglio, dal suo canto, non si lascia sfuggire l'assist e va in rete con un argomento semplice semplice: laddove gli organi esecutivi hanno sostanzialmente fallito (perché i controlli interni sono come colabrodo che non trattengono alcuno spreco) possono con più incisività riuscire i Consigli, se solo gli si consentisse di operare compiutamente. La teoria dell'autore è che le assemblee consiliari sono di fatto esautorate dall'attività di controllo, perché, ad esempio (ma si tratta dell'esempio per definizione), il bilancio si approva senza che le minoranze possano incidere davvero sui suoi contenuti, ma soprattutto perché l'apparato burocratico interno non considera i consiglieri come interlocutori principali, fornendo loro una documentazione poco chiara o comunque incompleta. Quest'ultima accusa mi sembra davvero gratuita. Chi fa i salti mortali per consegnare all'intera assemblea nei tempi rigorosi richiesti dalla legge tutto il materiale necessario per discutere nella sessione di bilancio sa bene che nelle settimane successive (più che sufficienti a entrare nel merito dei contenuti) sono ben poche (quando ci sono) le richieste di delucidazione che giungono all'ufficio finanziario. Scognamiglio parla di "debolezza degli uffici di supporto, che spesso rischiano di essere una segreteria che smista semplicemente le pratiche nelle commissioni e redige gli ordini del giorno", ma quante volte i gruppi di minoranza presentano (per scarsa voglia o per supponenza, importa poco) emendamenti irricevibili senza neppure aver chiesto all'ufficio un parere sulla forma più adeguata di presentazione? Vien voglia qui di ribaltare il pregiudizio: le minoranze ritengono che gli uffici comunali siano al servizio esclusivo della maggioranza e ne stanno alla larga per timore di non ricevere risposte trasparenti. La consapevolezza che l'intero set di strumenti di programmazione, così come voluti dal legislatore, sia in gran parte inaccessibile al neofita non può giustificare la perenne indolenza di chi siede in consiglio (anche tra i banchi della maggioranza) a voler comprendere (e non parlo di approfondire) concetti elementari ma fondamentali come: equilibrio di parte corrente, indici di indebitamento, avanzo di amministrazione, residui attivi e passivi, impegni e accertamenti, ecc. Ne risulta, è ovvio, un'incapacità a controllare che non ha quasi nulla a che vedere con l'isolamento paventato nell'articolo. Quanto ai rimedi per ovviare allo squilibrio di cui si lamenta, ve n'è uno che pare messo lì apposta per ingenerar polemiche. Si richiede, infatti, "formazione specifica per tutti i funzionari che sono addetti a qualsiasi titolo a supportare le attività delle commissioni, dei gruppi e della presidenza." Parrebbe, cioè, che a capo degli uffici comunali (segreteria, ragioneria, tecnico...) vi sia una classe di dirigenti (se non di diritto, almeno di fatto) mediamente impreparata, alla quale servono corsi, non di aggiornamento, ma di formazione per coadiuvare gli amministratori. In quale mondo vive Scognamiglio? Un mondo dove è necessario trasformare "gli attuali uffici di segreteria in uffici di programmazione e controllo (?), riequilibrando con l'esecutivo l'utilizzo delle collaborazioni di supporto (??)". Un mondo dove la confusione regna sovrana, piuttosto. Perché la vera chiave per risolvere l'enigma sta, come è stato già scritto, nella chiarezza di idee di chi programma. Se un salto di qualità va fatto, non si ribalti il problema accusando l'apparato di scarsa collaborazione. Si abbia invece il coraggio di rimettersi in discussione e fornire un ricambio culturale prima ancora che generazionale a chi si candida ad amministrare.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 20:21 0 commenti
Categorie: Consiglio comunale, Controllo interno
venerdì 24 agosto 2007
Con i fichi secchi
 La pratica, comodissima ed efficiente, dell'interpello tributario ha ormai contagiato anche gli enti locali, che non lesinano in fantasia quando si tratta di proporre quesiti all'Agenzia delle Entrate. Non essendo neppure obbligatorio, poi, prospettare una soluzione al problema, tutto vien più facile e cade anche l'ultimo pregiudizio. L'Agenzia è, per solito, piuttosto indulgente con gli interpellanti, anche (soprattutto) quando la risposta ai dubbi comunali rasenta la banalità. Il contegno serioso dei funzionari ministeriali trasforma, così, ordinarie questioni pratiche in casi esemplari, pronti per essere riproposti in chiave manualistica da qualche editore ben disposto. Nella molteplicità dei quesiti, però, di tanto in tanto, si distingue l'episodio sintomatico, quello che, davvero, può scatenare un effetto domino che, dalla risoluzione, porta dritto dritto alle aule di tribunale, alimentando la giurisprudenza di merito. Son casi rari, d'accordo. Ma quando capitano, restituiscono all'istituto dell'interpello quella dignità che i troppi quesiti inutili rischiano di intaccare. Tra il grano dei primi e il loglio di questi ultimi, c'è poi la categoria intermedia dei quesiti che, pur rappresentando una sostanziale perdita di tempo per gli interpellati, finiscono per introdurre dubbi collaterali, ai quali purtroppo bisogna rimediare in modo autarchico, rimboccandosi le maniche e sperando di riuscire a venirne a capo con diligenza. L'Agenzia ha proprio ieri (è uno di questi casi) risolto a un Comune preoccupato un'incombenza molto pratica: se istituisco un servizio di celebrazione matrimoni in sedi che non siano il municipio oppure in orari che non siano quelli di servizio e ne addebito il costo ai nubendi, chiede il Sindaco, devo applicare l'IVA? L'Agenzia, con abituale accondiscendenza, riepiloga con dovizia di particolari le premesse giuridiche che escludono l'imponibilità di queste operazioni (che sono addirittura fuori campo IVA), in quanto effettuate dal Comune nella sua veste eminentemente istituzionale. Il Comune potrà in tutta serenità accogliere le richieste, a quanto pare non sporadiche, dei propri cittadini di celebrare gli sponsali nelle sedi che saranno preferite alla casa comunale (evidentemente poco luminosa). Fin qui la rilevanza ai fini del valore aggiunto. All'Agenzia, d'altronde, è stato chiesto un parere su un aspetto specifico, oltre non può e non deve andare. Mi resta così la curiosità di capire se e entro quali limiti l'intraprendente Sindaco possa legittimamente porre a carico dei freschi sposi una determinata somma a forfait, a titolo di rimborso spese. Innanzitutto, la stessa Agenzia (forse stuzzicata dalla singolare iniziativa) fa presente che "il Comune istante - nel permettere la celebrazione del matrimonio civile fuori dall'orario d'ufficio ovvero nel consentire l'utilizzo di immobili diversi da quelli ordinariamente adibiti all'esercizio dell'anzidetta funzione (...) non necessariamente pone in essere prestazioni distinte e ulteriori rispetto alle (...) funzioni pubblicistiche relative alla celebrazione dei matrimoni civili, ricomprese nel servizio di stato civile." Cioè non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della istituzionalità della funzione esercitata, nel celebrare nozze civili in municipio o in un'altra sede, in orario d'ufficio oppure la domenica mattina. Inoltre, i locali prescelti per la cerimonia sono comunque di proprietà comunale (lo si evince dal testo del quesito), dunque sedi istituzionali a tutti gli effetti, per l'uso delle quali l'ente non sostiene costi ulteriori ed eccezionali rispetto a quelli ordinari. Lo stesso interpellante esclude, poi, che il servizio comporti per il Comune l'assunzione della spesa per addobbi, servizi fotografici ecc. così che a carico dell'ente restano, esclusivamente, le ore di lavoro straordinario dei dipendenti interessati e la manutenzione della sala per il tempo necessario all'espletamento della cerimonia. In particolare, queste ultime sono comunque sostenute in via ordinaria dall'ente anche per la sede municipale (un minimo di decoro, suvvia). Così, delle due l'una: o il servizio matrimoni è sempre a titolo oneroso per i promessi sposi oppure non lo è mai. Considerando la natura pubblicistica della funzione, sancita come ricordato dal Codice civile, ma anche dal TUEL e naturalmente dalle leggi sull'ordinamento dello stato civile, svolta dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo, mi sentirei di escludere la prima ipotesi. Si accettano opinioni diverse, che mi convincano del contrario.
La pratica, comodissima ed efficiente, dell'interpello tributario ha ormai contagiato anche gli enti locali, che non lesinano in fantasia quando si tratta di proporre quesiti all'Agenzia delle Entrate. Non essendo neppure obbligatorio, poi, prospettare una soluzione al problema, tutto vien più facile e cade anche l'ultimo pregiudizio. L'Agenzia è, per solito, piuttosto indulgente con gli interpellanti, anche (soprattutto) quando la risposta ai dubbi comunali rasenta la banalità. Il contegno serioso dei funzionari ministeriali trasforma, così, ordinarie questioni pratiche in casi esemplari, pronti per essere riproposti in chiave manualistica da qualche editore ben disposto. Nella molteplicità dei quesiti, però, di tanto in tanto, si distingue l'episodio sintomatico, quello che, davvero, può scatenare un effetto domino che, dalla risoluzione, porta dritto dritto alle aule di tribunale, alimentando la giurisprudenza di merito. Son casi rari, d'accordo. Ma quando capitano, restituiscono all'istituto dell'interpello quella dignità che i troppi quesiti inutili rischiano di intaccare. Tra il grano dei primi e il loglio di questi ultimi, c'è poi la categoria intermedia dei quesiti che, pur rappresentando una sostanziale perdita di tempo per gli interpellati, finiscono per introdurre dubbi collaterali, ai quali purtroppo bisogna rimediare in modo autarchico, rimboccandosi le maniche e sperando di riuscire a venirne a capo con diligenza. L'Agenzia ha proprio ieri (è uno di questi casi) risolto a un Comune preoccupato un'incombenza molto pratica: se istituisco un servizio di celebrazione matrimoni in sedi che non siano il municipio oppure in orari che non siano quelli di servizio e ne addebito il costo ai nubendi, chiede il Sindaco, devo applicare l'IVA? L'Agenzia, con abituale accondiscendenza, riepiloga con dovizia di particolari le premesse giuridiche che escludono l'imponibilità di queste operazioni (che sono addirittura fuori campo IVA), in quanto effettuate dal Comune nella sua veste eminentemente istituzionale. Il Comune potrà in tutta serenità accogliere le richieste, a quanto pare non sporadiche, dei propri cittadini di celebrare gli sponsali nelle sedi che saranno preferite alla casa comunale (evidentemente poco luminosa). Fin qui la rilevanza ai fini del valore aggiunto. All'Agenzia, d'altronde, è stato chiesto un parere su un aspetto specifico, oltre non può e non deve andare. Mi resta così la curiosità di capire se e entro quali limiti l'intraprendente Sindaco possa legittimamente porre a carico dei freschi sposi una determinata somma a forfait, a titolo di rimborso spese. Innanzitutto, la stessa Agenzia (forse stuzzicata dalla singolare iniziativa) fa presente che "il Comune istante - nel permettere la celebrazione del matrimonio civile fuori dall'orario d'ufficio ovvero nel consentire l'utilizzo di immobili diversi da quelli ordinariamente adibiti all'esercizio dell'anzidetta funzione (...) non necessariamente pone in essere prestazioni distinte e ulteriori rispetto alle (...) funzioni pubblicistiche relative alla celebrazione dei matrimoni civili, ricomprese nel servizio di stato civile." Cioè non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della istituzionalità della funzione esercitata, nel celebrare nozze civili in municipio o in un'altra sede, in orario d'ufficio oppure la domenica mattina. Inoltre, i locali prescelti per la cerimonia sono comunque di proprietà comunale (lo si evince dal testo del quesito), dunque sedi istituzionali a tutti gli effetti, per l'uso delle quali l'ente non sostiene costi ulteriori ed eccezionali rispetto a quelli ordinari. Lo stesso interpellante esclude, poi, che il servizio comporti per il Comune l'assunzione della spesa per addobbi, servizi fotografici ecc. così che a carico dell'ente restano, esclusivamente, le ore di lavoro straordinario dei dipendenti interessati e la manutenzione della sala per il tempo necessario all'espletamento della cerimonia. In particolare, queste ultime sono comunque sostenute in via ordinaria dall'ente anche per la sede municipale (un minimo di decoro, suvvia). Così, delle due l'una: o il servizio matrimoni è sempre a titolo oneroso per i promessi sposi oppure non lo è mai. Considerando la natura pubblicistica della funzione, sancita come ricordato dal Codice civile, ma anche dal TUEL e naturalmente dalle leggi sull'ordinamento dello stato civile, svolta dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo, mi sentirei di escludere la prima ipotesi. Si accettano opinioni diverse, che mi convincano del contrario.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 20:23 0 commenti
Categorie: IVA, Rimborsi spese
giovedì 23 agosto 2007
La gatta al lardo
 Lo slancio privatistico che, negli ultimi anni, ha fatto proliferare le partecipazioni degli enti locali in società di capitali, per la gestione dei più disparati servizi, pare dovrà subire una importante battuta d'arresto per effetto della recente circolare ministeriale sui compensi agli amministratori (MEF n. del 13 luglio 2007). Questa almeno è la teoria che ci viene presentata sulle pagine del Lenzuolo rosa, in un accorato appello di Vittorio Provera e Salvatore Trifirò (professionisti di diritto societario), nel numero odierno. La tesi su cui gli autori basano la loro preoccupazione è la seguente: poiché la circolare (conformemente alla norma che l'ha originata, la Finanziaria 2007) limita in modo preciso e inderogabile i compensi attribuibili ai componenti i consigli di amministrazione, compreso il caso nel quale sia stato nominato un amministratore unico, l'inevitabile conseguenza sarà che i migliori manager sul mercato si guarderanno bene dall'accettare nomine in società partecipate dagli enti locali, aumentando così il rischio che queste ultime siano governate da una classe dirigente di second'ordine. L'argomentazione è, tra l'altro, sostenuta da almeno un paio di appigli normativi. Da un lato, infatti, il Codice civile (palesemente contraddetto dall'interpretazione ministeriale) consente esplicitamente che agli amministratori delegati sia possibile attribuire una remunerazione strettamente correlata alla responsabilità assunta in seno alla società, dunque svincolata da qualsiasi parametro predeterminato. In secondo luogo, vi sono società partecipate pubbliche per le quali questo vincolo retributivo già oggi non sussiste, e proprio per effetto della norma di cui disserta la circolare incriminata (nello specifico: il comma 466 della Finanziaria 2007) . Si tratta delle società delle quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze è socio, purché non quotate in Borsa. In effetti, questi macroscopici difetti della disposizione normativa mettono in cattiva luce un impianto già poco chiaro (nella stessa circolare emerge il già noto e fumosissimo concetto di 'perdita', in base al quale si dovrebbe giudicare della nominabilità o meno di un amministratore). L'abitudine a scovare le smagliature nelle reti capienti delle note ministeriali ci permette di non sorprenderci più del necessario. Ciò non toglie che il punto critico sia stato correttamente sottolineato. Anche perché, evidentemente, nell'ottica dei due avvocati, le società a partecipazione pubblica restano invariabilmente enti di diritto privato, soggette allo spietato regime della concorrenza e dunque sottoposte a regole che con il settore pubblico non hanno e non devono avere nulla a che fare. L'altro lato della medaglia, però, esiste. Si chiama, secondo me, ragionevolezza di pretese economiche a fronte di obiettivi di gestione chiari. Facciamo due semplici conti, partendo da un esempio concreto (già usato in precedenza). La società per azioni che gestirà entro breve il servizio idrico integrato della provincia di Bergamo è partecipata anche dalla corrispondente amministrazione provinciale, nella quale risiede complessivamente circa 1.000.000 di abitanti, e che possiede la quota di maggioranza. E' questa, secondo la legge, la dimensione demografica a cui fare riferimento. Dunque, il presidente dell'Amministrazione provinciale di Bergamo ha diritto (ex D.M. n. 119/2000) a un'indennità mensile base di € 6.972,17 (poco meno di € 85.000,00 annui, esclusa la mensilità da accantonare a titolo di T.F.R.), aumentabile di un ulteriore 5% in presenza di parametri di spesa favorevoli. Inoltre, è sempre possibile l'applicazione degli incrementi percentuali previsti dalla Tabella D del decreto. Ipotizziamo prudenzialmente un ulteriore 20% in più. Stiamo parlando, tra l'altro, di compensi fissati nel 2000, il cui aggiornamento è previsto prossimamente. L'amministratore delegato della costituenda Spa, dunque, avrebbe diritto a un compenso massimo di circa € 80.000,00 annui. Attenzione, si tratta della parte fissa della retribuzione. Infatti, nel loro sfogo, gli autori hanno omesso di citare quella parte della circolare nella quale si ricorda che: "La norma fa salva la facoltà, per il socio pubblico, di prevedere indennità di risultato in favore dei propri amministratori nel solo caso di produzione di utili (e ci mancherebbe NdR) e in misura ragionevole e proporzionata." Vogliamo aggiungerci un premio del 20%? Il nostro dirigente percepirebbe, così, emolumenti complessivi annui per € 95.000,00. Si tratta, a mio parere, di una situazione tutt'altro che limite, perché le ATO sono, appunto, gestite su base provinciale. Inoltre, qualora il socio di maggioranza sia, in alternativa, il Comune capoluogo della provincia, si partirebbe (salvo poche eccezioni) da una base mensile fissa di circa € 4.000,00, ipotizzando una popolazione non inferiore ai centomila abitanti. Fate voi i conti. Cifre di cui dolersi? A partire da quale soglia, sono curioso di sapere, i compensi dovrebbero essere considerati appetibili (concorrenziali) per solleticare le ambizioni della crema dei dirigenti? Per pudore e per discrezione, immagino, nell'articolo non si parla di pecunia. Ciò non impedisce agli autori di condurre una battaglia che pare più rivolgersi all'orgoglio di manager che puntano a cachet a 6 cifre e oltre che non agli enti interessati alla disposizione; battaglia della quale, in tutta sincerità, non si possono condividere le motivazioni solo perché il mercato paga benissimo i più richiesti (che non sempre sono anche quelli che ottengono i migliori risultati). Legare la parte variabile della retribuzione ai risultati finali, fissandola anche a livelli significativi, dovrebbe essere criterio sufficiente per garantirsi le prestazioni e le competenze dei più capaci.
Lo slancio privatistico che, negli ultimi anni, ha fatto proliferare le partecipazioni degli enti locali in società di capitali, per la gestione dei più disparati servizi, pare dovrà subire una importante battuta d'arresto per effetto della recente circolare ministeriale sui compensi agli amministratori (MEF n. del 13 luglio 2007). Questa almeno è la teoria che ci viene presentata sulle pagine del Lenzuolo rosa, in un accorato appello di Vittorio Provera e Salvatore Trifirò (professionisti di diritto societario), nel numero odierno. La tesi su cui gli autori basano la loro preoccupazione è la seguente: poiché la circolare (conformemente alla norma che l'ha originata, la Finanziaria 2007) limita in modo preciso e inderogabile i compensi attribuibili ai componenti i consigli di amministrazione, compreso il caso nel quale sia stato nominato un amministratore unico, l'inevitabile conseguenza sarà che i migliori manager sul mercato si guarderanno bene dall'accettare nomine in società partecipate dagli enti locali, aumentando così il rischio che queste ultime siano governate da una classe dirigente di second'ordine. L'argomentazione è, tra l'altro, sostenuta da almeno un paio di appigli normativi. Da un lato, infatti, il Codice civile (palesemente contraddetto dall'interpretazione ministeriale) consente esplicitamente che agli amministratori delegati sia possibile attribuire una remunerazione strettamente correlata alla responsabilità assunta in seno alla società, dunque svincolata da qualsiasi parametro predeterminato. In secondo luogo, vi sono società partecipate pubbliche per le quali questo vincolo retributivo già oggi non sussiste, e proprio per effetto della norma di cui disserta la circolare incriminata (nello specifico: il comma 466 della Finanziaria 2007) . Si tratta delle società delle quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze è socio, purché non quotate in Borsa. In effetti, questi macroscopici difetti della disposizione normativa mettono in cattiva luce un impianto già poco chiaro (nella stessa circolare emerge il già noto e fumosissimo concetto di 'perdita', in base al quale si dovrebbe giudicare della nominabilità o meno di un amministratore). L'abitudine a scovare le smagliature nelle reti capienti delle note ministeriali ci permette di non sorprenderci più del necessario. Ciò non toglie che il punto critico sia stato correttamente sottolineato. Anche perché, evidentemente, nell'ottica dei due avvocati, le società a partecipazione pubblica restano invariabilmente enti di diritto privato, soggette allo spietato regime della concorrenza e dunque sottoposte a regole che con il settore pubblico non hanno e non devono avere nulla a che fare. L'altro lato della medaglia, però, esiste. Si chiama, secondo me, ragionevolezza di pretese economiche a fronte di obiettivi di gestione chiari. Facciamo due semplici conti, partendo da un esempio concreto (già usato in precedenza). La società per azioni che gestirà entro breve il servizio idrico integrato della provincia di Bergamo è partecipata anche dalla corrispondente amministrazione provinciale, nella quale risiede complessivamente circa 1.000.000 di abitanti, e che possiede la quota di maggioranza. E' questa, secondo la legge, la dimensione demografica a cui fare riferimento. Dunque, il presidente dell'Amministrazione provinciale di Bergamo ha diritto (ex D.M. n. 119/2000) a un'indennità mensile base di € 6.972,17 (poco meno di € 85.000,00 annui, esclusa la mensilità da accantonare a titolo di T.F.R.), aumentabile di un ulteriore 5% in presenza di parametri di spesa favorevoli. Inoltre, è sempre possibile l'applicazione degli incrementi percentuali previsti dalla Tabella D del decreto. Ipotizziamo prudenzialmente un ulteriore 20% in più. Stiamo parlando, tra l'altro, di compensi fissati nel 2000, il cui aggiornamento è previsto prossimamente. L'amministratore delegato della costituenda Spa, dunque, avrebbe diritto a un compenso massimo di circa € 80.000,00 annui. Attenzione, si tratta della parte fissa della retribuzione. Infatti, nel loro sfogo, gli autori hanno omesso di citare quella parte della circolare nella quale si ricorda che: "La norma fa salva la facoltà, per il socio pubblico, di prevedere indennità di risultato in favore dei propri amministratori nel solo caso di produzione di utili (e ci mancherebbe NdR) e in misura ragionevole e proporzionata." Vogliamo aggiungerci un premio del 20%? Il nostro dirigente percepirebbe, così, emolumenti complessivi annui per € 95.000,00. Si tratta, a mio parere, di una situazione tutt'altro che limite, perché le ATO sono, appunto, gestite su base provinciale. Inoltre, qualora il socio di maggioranza sia, in alternativa, il Comune capoluogo della provincia, si partirebbe (salvo poche eccezioni) da una base mensile fissa di circa € 4.000,00, ipotizzando una popolazione non inferiore ai centomila abitanti. Fate voi i conti. Cifre di cui dolersi? A partire da quale soglia, sono curioso di sapere, i compensi dovrebbero essere considerati appetibili (concorrenziali) per solleticare le ambizioni della crema dei dirigenti? Per pudore e per discrezione, immagino, nell'articolo non si parla di pecunia. Ciò non impedisce agli autori di condurre una battaglia che pare più rivolgersi all'orgoglio di manager che puntano a cachet a 6 cifre e oltre che non agli enti interessati alla disposizione; battaglia della quale, in tutta sincerità, non si possono condividere le motivazioni solo perché il mercato paga benissimo i più richiesti (che non sempre sono anche quelli che ottengono i migliori risultati). Legare la parte variabile della retribuzione ai risultati finali, fissandola anche a livelli significativi, dovrebbe essere criterio sufficiente per garantirsi le prestazioni e le competenze dei più capaci.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 20:57 0 commenti
Categorie: Società di capitali, Società partecipate
mercoledì 22 agosto 2007
Il cucchiaio d'argento
 Nella moderata canicola d'agosto, il Ministero Economia e Finanze smaltisce le richieste di interpello ricevute negli ultimi mesi e la raccolta di risoluzioni diventa pingue, più che durante la normale attività feriale. Capita così di imbattersi in documenti interessanti che meritano un'attenzione altrimenti rivolta a più amene faccende. Prendiamo il caso della Risoluzione n. 222/E del 10 agosto, a proposito di IVA e mense scolastiche. Il quesito posto dal Comune X è piuttosto articolato: la gestione del servizio mensa è stata effettuata direttamente dall'ente fino all'anno scolastico 2005/2006. L'anno successivo il servizio è stato esternalizzato ad apposita società commerciale. Per il prossimo anno scolastico si sa solamente che il Comune intende richiedere agli utilizzatori dei locali un canone impropriamente definito 'per la concessione'. Ciò fa comunque supporre che il servizio sia ancora affidato all'esterno, senza però chiarire attraverso quali modalità operative. La differenza, si capisce, non è di poco conto. Nel caso in cui il servizio sia gestito integralmente da una società specifica che eroga i pasti e ne introita il parziale corrispettivo direttamente dagli utenti, addebitando al Comune la sola differenza tra costi e ricavi, quest'ultimo non potrà considerare rilevante a fini IVA il servizio stesso. Qualora invece il Comune abbia appaltato la sola erogazione dei pasti, introitando direttamente la tariffa dai genitori, e mettendo a disposizione dell'erogatore appositi locali, il servizio sarà senz'altro rilevante. In realtà, all'ente preme di conoscere il parere del Ministero su una questione collaterale ma finanziariamente impegnativa: è possibile detrarre l'imposta versata sulle fatture addebitate per la realizzazione di un edificio da adibire appositamente a locale mensa? L'interpellato, come accade spesso, la prende molto alla larga. Anche perché, come vedremo in conclusione, la questione così come posta dal Comune non appare chiarissima. Il ragionamento del MEF sembrerebbe, al contrario, un modello di impeccabile logica: 1) Il DPR 633/1972 prevede che lo svolgimento di attività commerciali presume l'esercizio di impresa, anche quando è effettuato da enti pubblici; 2) Tra le attività commerciali rientra senz'altro la gestione di una mensa scolastica; 3) Quindi il Comune che somministra pasti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado è soggetto attivo IVA, con applicazione dell'aliquota agevolata del 4%. Fin qui, però, nulla di nuovo. Così come alcuna risposta specifica al quesito si dà ricordando, nei successivi paragrafi, come si esercita il diritto di detrazione. Il Ministero, in un eccesso di argomentazione, spiega anche che coloro i quali tengano impropriamente la contabilità IVA dell'attività commerciale è negata la possibilità di esercitare il suddetto diritto. La qual cosa non rileva, come i cavoli a merenda. Come solo indirettamente può interessare sapere che il diritto alla detrazione "sorge fin dal momento dell'acquisizione dei beni e servizi", perché l'ente ha subito chiarito che il nuovo edificio sarà utilizzato come locale per la mensa scolastica. Sulla "fattispecie concreta", dunque, si forniscono delucidazioni solo nell'ultima pagina. Più che altro, il Ministero si premura (in un passaggio addirittura sgrammaticato) di confermare che la soluzione prospettata dal contribuente (sì alla detrazione d'imposta) è corretta, senza però dirlo chiaramente. Utilizza, infatti, la seguente espressione: "qualora intenda destinare (e di fatto andrà a destinare) il costruendo immobile", capolavoro di ambiguità. Nel gran fumo dei periodi ministeriali, non mi sembra invece di intravedere un chiarimento del dubbio centrale della vicenda. E' pacifico, innanzitutto, che, nell'anno scolastico 2005-2006, il diritto alla detrazione sussisteva, il Comune gestendo in economia il servizio. E' altresì certo che questo diritto non poteva sussistere (come implicitamente riconosciuto dallo stesso interpellante) nell'anno scolastico 2006-2007 durante il quale una società esterna svolgeva il servizio in modo diretto. E per il futuro? Il Comune non dice chiaramente (o almeno l'Agenzia delle Entrate non lo riporta) quale sarà la modalità di espletamento del servizio. Scrive infatti il Comune: "Con la nuova gara di aggiudicazione del servizio (...)". Espressione vaga che si presta a ogni soluzione (compresa quella in economia). Si conosce solo la destinazione finale dell'immobile. Evidentemente, se dovesse essere confermata la gestione diretta da parte della società, il servizio rimarrebbe irrilevante ai fini IVA per il Comune (essendo rilevante per la società commerciale), a nulla rilevando il fatto che, per l'uso dei locali l'ente addebiti a questa società un importo a titolo di canone d'uso. L'unico appiglio è contenuto nella soluzione interpretativa prospettata dove si dice che il servizio "mantiene tale rilevanza nell'anno scolastico 2007-2008", ma è una sorta di autocertificazione dell'ente. Il vero dubbio del Comune, secondo me, riguardava l'anno scolastico appena terminato. E, checché ne pensi il Ministero, non credo sia possibile venire incontro alle esigenze dell'ente.
Nella moderata canicola d'agosto, il Ministero Economia e Finanze smaltisce le richieste di interpello ricevute negli ultimi mesi e la raccolta di risoluzioni diventa pingue, più che durante la normale attività feriale. Capita così di imbattersi in documenti interessanti che meritano un'attenzione altrimenti rivolta a più amene faccende. Prendiamo il caso della Risoluzione n. 222/E del 10 agosto, a proposito di IVA e mense scolastiche. Il quesito posto dal Comune X è piuttosto articolato: la gestione del servizio mensa è stata effettuata direttamente dall'ente fino all'anno scolastico 2005/2006. L'anno successivo il servizio è stato esternalizzato ad apposita società commerciale. Per il prossimo anno scolastico si sa solamente che il Comune intende richiedere agli utilizzatori dei locali un canone impropriamente definito 'per la concessione'. Ciò fa comunque supporre che il servizio sia ancora affidato all'esterno, senza però chiarire attraverso quali modalità operative. La differenza, si capisce, non è di poco conto. Nel caso in cui il servizio sia gestito integralmente da una società specifica che eroga i pasti e ne introita il parziale corrispettivo direttamente dagli utenti, addebitando al Comune la sola differenza tra costi e ricavi, quest'ultimo non potrà considerare rilevante a fini IVA il servizio stesso. Qualora invece il Comune abbia appaltato la sola erogazione dei pasti, introitando direttamente la tariffa dai genitori, e mettendo a disposizione dell'erogatore appositi locali, il servizio sarà senz'altro rilevante. In realtà, all'ente preme di conoscere il parere del Ministero su una questione collaterale ma finanziariamente impegnativa: è possibile detrarre l'imposta versata sulle fatture addebitate per la realizzazione di un edificio da adibire appositamente a locale mensa? L'interpellato, come accade spesso, la prende molto alla larga. Anche perché, come vedremo in conclusione, la questione così come posta dal Comune non appare chiarissima. Il ragionamento del MEF sembrerebbe, al contrario, un modello di impeccabile logica: 1) Il DPR 633/1972 prevede che lo svolgimento di attività commerciali presume l'esercizio di impresa, anche quando è effettuato da enti pubblici; 2) Tra le attività commerciali rientra senz'altro la gestione di una mensa scolastica; 3) Quindi il Comune che somministra pasti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado è soggetto attivo IVA, con applicazione dell'aliquota agevolata del 4%. Fin qui, però, nulla di nuovo. Così come alcuna risposta specifica al quesito si dà ricordando, nei successivi paragrafi, come si esercita il diritto di detrazione. Il Ministero, in un eccesso di argomentazione, spiega anche che coloro i quali tengano impropriamente la contabilità IVA dell'attività commerciale è negata la possibilità di esercitare il suddetto diritto. La qual cosa non rileva, come i cavoli a merenda. Come solo indirettamente può interessare sapere che il diritto alla detrazione "sorge fin dal momento dell'acquisizione dei beni e servizi", perché l'ente ha subito chiarito che il nuovo edificio sarà utilizzato come locale per la mensa scolastica. Sulla "fattispecie concreta", dunque, si forniscono delucidazioni solo nell'ultima pagina. Più che altro, il Ministero si premura (in un passaggio addirittura sgrammaticato) di confermare che la soluzione prospettata dal contribuente (sì alla detrazione d'imposta) è corretta, senza però dirlo chiaramente. Utilizza, infatti, la seguente espressione: "qualora intenda destinare (e di fatto andrà a destinare) il costruendo immobile", capolavoro di ambiguità. Nel gran fumo dei periodi ministeriali, non mi sembra invece di intravedere un chiarimento del dubbio centrale della vicenda. E' pacifico, innanzitutto, che, nell'anno scolastico 2005-2006, il diritto alla detrazione sussisteva, il Comune gestendo in economia il servizio. E' altresì certo che questo diritto non poteva sussistere (come implicitamente riconosciuto dallo stesso interpellante) nell'anno scolastico 2006-2007 durante il quale una società esterna svolgeva il servizio in modo diretto. E per il futuro? Il Comune non dice chiaramente (o almeno l'Agenzia delle Entrate non lo riporta) quale sarà la modalità di espletamento del servizio. Scrive infatti il Comune: "Con la nuova gara di aggiudicazione del servizio (...)". Espressione vaga che si presta a ogni soluzione (compresa quella in economia). Si conosce solo la destinazione finale dell'immobile. Evidentemente, se dovesse essere confermata la gestione diretta da parte della società, il servizio rimarrebbe irrilevante ai fini IVA per il Comune (essendo rilevante per la società commerciale), a nulla rilevando il fatto che, per l'uso dei locali l'ente addebiti a questa società un importo a titolo di canone d'uso. L'unico appiglio è contenuto nella soluzione interpretativa prospettata dove si dice che il servizio "mantiene tale rilevanza nell'anno scolastico 2007-2008", ma è una sorta di autocertificazione dell'ente. Il vero dubbio del Comune, secondo me, riguardava l'anno scolastico appena terminato. E, checché ne pensi il Ministero, non credo sia possibile venire incontro alle esigenze dell'ente.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 15:21 0 commenti
Categorie: IVA, Mensa scolastica
martedì 21 agosto 2007
Carta canta
 La corsa alla semplificazione amministrativa rischia di travolgere le buone come le cattive intenzioni se non si aggiusta il tiro per impedire lo spreco di munizioni. La lodevole iniziativa che, nel giro di poco più di due anni, dovrebbe concludersi con l'assottigliamento dell'attuale miriade di testi legislativi, arrivando a selezionare esclusivamente quelli sul cui vigore non può dubitarsi, corre il serio rischio, secondo me, di lasciare insoddisfatti gli operatori del diritto che, peraltro con giusta trepidazione, appoggiano l'ardua impresa. Ciascun Ministero è stato incaricato di setacciare il settore normativo di propria competenza per estrarne le agognate pepite da lustrare e esporre al pubblico. Parliamo, complessivamente, di non meno di 200.000 provvedimenti, escludendo i regolamenti attuativi, per ora tenuti nei capienti cassetti del legislatore. Pare che il criterio di selezione sia grossomodo rappresentato da una data spartiacque: tutto ciò che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato dal 1970 in poi avrebbe l'alta probabilità di essere attualmente vigente, quindi da conservare. Prima di allora, invece, scatterebbe automaticamente una sorta di presunzione di obsolescenza, da verificare e dimostrare ovviamente caso per caso, con una singolare ma inevitabile inversione dell'onere della prova. Può darsi che il metodo adottato dal comitato tecnico sia troppo vago, ma, da un lato, un sistema operativo doveva essere in ogni caso trovato e, dall'altro, ogni norma sarà vagliata comunque, nella speranza (tacita) che possa finire nella vaschetta degli scarti, ridimensionando la banca dati finale. Pare che la critica principale piovuta sui resistenti capi degli sfoltitori sia che l'operazione risulta fin da subito parziale: non va giù che si lavori di mietitrice esclusivamente sulle leggi, quando contemporaneamente si poteva metter mano anche alle decine di migliaia (a esser ottimisti) di decreti attuativi e ottenere un risultato completo e fruibile. Si dice: al termine del lavoro, sarà necessario ripartire da capo per rintuzzare i regolamenti, tanto valeva farlo subito. A questa obiezione nessuno offre risposte plausibili, lasciando intendere che l'opera intrapresa è già sufficientemente titanica senza doverla ampliare oltre ogni misura. Buona regola sarebbe, però, replicare alle critiche senza ricorrere alla giustificazione preventiva. Meglio dire subito che le risorse sono limitate e che per completare il lavoro ne servirebbero molte di più. Saremmo, se non altro, tranquillizzati sul fatto che anche chi si è fatto paladino del taglio è consapevole dei suoi limiti. Peraltro, il bersaglio scelto dai detrattori mi sembra sfuocato. Perché è vero che una raccolta aggiornata di norme di grado primario senza il parallelo rinnovamento di quelle di rango secondario è come pulire i vetri di una finestra da un lato solo, ma se l'obiettivo a cui tendere è un'asettica collezione di testi di legge (al massimo raggruppati per settore), non ne vedo i vantaggi pratici. Voglio dire che una selezione così accurata dovrebbe tendere alla sospirata realizzazione di una serie di testi unici che non sono, come ognuno sa, la semplice collazione di norme omogenee, ma raccolte coordinate e definitive dalle quali ricavare il principio che interessa quando interessa, senza rincorrere fonti plurime e dotarsi di scrivanie dalla superficie chilometrica. "Nei tuoi sogni, forse", sento già le voci in sottofondo. Sarà, ma mi chiedo a cosa serva allora profondersi in uno sforzo comunque così importante se, per ottenere lo stesso risultato per ora previsto, basta abbonarsi alle ottime raccolte on-line oggi in commercio. Qualcuno prevede che questa fase, probabilmente, ci sarà. In verità, avrebbe dovuto rappresentare il vero obiettivo a cui tendere, fin dall'inizio.
La corsa alla semplificazione amministrativa rischia di travolgere le buone come le cattive intenzioni se non si aggiusta il tiro per impedire lo spreco di munizioni. La lodevole iniziativa che, nel giro di poco più di due anni, dovrebbe concludersi con l'assottigliamento dell'attuale miriade di testi legislativi, arrivando a selezionare esclusivamente quelli sul cui vigore non può dubitarsi, corre il serio rischio, secondo me, di lasciare insoddisfatti gli operatori del diritto che, peraltro con giusta trepidazione, appoggiano l'ardua impresa. Ciascun Ministero è stato incaricato di setacciare il settore normativo di propria competenza per estrarne le agognate pepite da lustrare e esporre al pubblico. Parliamo, complessivamente, di non meno di 200.000 provvedimenti, escludendo i regolamenti attuativi, per ora tenuti nei capienti cassetti del legislatore. Pare che il criterio di selezione sia grossomodo rappresentato da una data spartiacque: tutto ciò che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato dal 1970 in poi avrebbe l'alta probabilità di essere attualmente vigente, quindi da conservare. Prima di allora, invece, scatterebbe automaticamente una sorta di presunzione di obsolescenza, da verificare e dimostrare ovviamente caso per caso, con una singolare ma inevitabile inversione dell'onere della prova. Può darsi che il metodo adottato dal comitato tecnico sia troppo vago, ma, da un lato, un sistema operativo doveva essere in ogni caso trovato e, dall'altro, ogni norma sarà vagliata comunque, nella speranza (tacita) che possa finire nella vaschetta degli scarti, ridimensionando la banca dati finale. Pare che la critica principale piovuta sui resistenti capi degli sfoltitori sia che l'operazione risulta fin da subito parziale: non va giù che si lavori di mietitrice esclusivamente sulle leggi, quando contemporaneamente si poteva metter mano anche alle decine di migliaia (a esser ottimisti) di decreti attuativi e ottenere un risultato completo e fruibile. Si dice: al termine del lavoro, sarà necessario ripartire da capo per rintuzzare i regolamenti, tanto valeva farlo subito. A questa obiezione nessuno offre risposte plausibili, lasciando intendere che l'opera intrapresa è già sufficientemente titanica senza doverla ampliare oltre ogni misura. Buona regola sarebbe, però, replicare alle critiche senza ricorrere alla giustificazione preventiva. Meglio dire subito che le risorse sono limitate e che per completare il lavoro ne servirebbero molte di più. Saremmo, se non altro, tranquillizzati sul fatto che anche chi si è fatto paladino del taglio è consapevole dei suoi limiti. Peraltro, il bersaglio scelto dai detrattori mi sembra sfuocato. Perché è vero che una raccolta aggiornata di norme di grado primario senza il parallelo rinnovamento di quelle di rango secondario è come pulire i vetri di una finestra da un lato solo, ma se l'obiettivo a cui tendere è un'asettica collezione di testi di legge (al massimo raggruppati per settore), non ne vedo i vantaggi pratici. Voglio dire che una selezione così accurata dovrebbe tendere alla sospirata realizzazione di una serie di testi unici che non sono, come ognuno sa, la semplice collazione di norme omogenee, ma raccolte coordinate e definitive dalle quali ricavare il principio che interessa quando interessa, senza rincorrere fonti plurime e dotarsi di scrivanie dalla superficie chilometrica. "Nei tuoi sogni, forse", sento già le voci in sottofondo. Sarà, ma mi chiedo a cosa serva allora profondersi in uno sforzo comunque così importante se, per ottenere lo stesso risultato per ora previsto, basta abbonarsi alle ottime raccolte on-line oggi in commercio. Qualcuno prevede che questa fase, probabilmente, ci sarà. In verità, avrebbe dovuto rappresentare il vero obiettivo a cui tendere, fin dall'inizio.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 15:25 0 commenti
Categorie: Semplificazione, Taglio delle leggi
lunedì 20 agosto 2007
Il pieno, per favore
 Dalle parti della Madonnina è tutto un triste rimirar portafogli vuoti, dopo le rivelazioni dell'Ufficio Studi della Cgia di Mestre (che, ricordiamo, non è una ONLUS ma l'associazione di categoria che riunisce piccole imprese e artigiani della zona) secondo le quali il capoluogo lombardo soffre di un eccesso di tributi locali rispetto al resto del territorio nazionale. Il dato nudo e crudo (rilevato da consuntivo 2005), infatti, è piuttosto schietto: a Milano se ne vanno via, ogni anno, in tasse comunali, provinciali e regionali la bellezza di € 2.082,23 a cittadino, contro una media nazionale di € 1.434,13 oppure, tanto per fare un esempio, contro i 1.486,50 euro sborsati dal cittadino di Siena. Il fior fiore della stampa quotidiana nazionale si è gettata a pesce sulla notizia, un po' perché parlar di vil denaro ingolosisce sempre il lettore (invidioso e livoroso al tempo stesso), un po' perché a buon mercato le si offre la sponda per tornare a parlar male di quella casta che spilla risorse dove può, quando può, più che può, e se in classifica arriva prima Milano oppure Enna importa punto. Non che la notizia manchi di un suo specifico allure, specie se, oltre le veline di prammatica, si abbia la pazienza (mica poi tanta) di trovare il documento originale e guardarsi la tabella allegata e riepilogativa. Da cui si ricava, ad esempio, che dell'impressionante dato meneghino è parecchio responsabile l'ente Regione che svetta, sulle venti totali, con i suoi milleottantotto euro per abitante. A onor del vero, in tutta la Lombardia non v'è altro capoluogo che sprema così i propri contribuenti (nell'almeno altrettanto operosa Brescia pagano quasi il 50% in meno all'Amministrazione comunale). Siccome però il can can seguito alla notizia fa leva sul valore assoluto del salasso fiscale, converrà andar più a fondo e, utilizzando semplicemente gli scarni numeri forniti dai veneti, verificarne la consistenza. Osservando l'elenco di città capoluogo che segue alla breve analisi della Cgia, balza subito all'occhio con malinconica evidenza che le province sono davvero l'anello inutile nella catena delle autonomie locali nel quadro istituzionale odierno. Con quegli striminziti ottanta euro annui di pressione fiscale (un decimo del peso regionale) vien quasi voglia di regalargliene qualche altro, salvo ricordarsi immediatamente dell'incontrovertibile assenza di qualsiasi ragione per mantenere in vita l'ente intermedio per eccellenza. Tornando invece alla tenzone che contrappone, in una riedizione moderna dei duelli rusticani, comuni e regioni, si dovrà tener innanzitutto conto di un elemento predominante: l'IRAP. Quest'ultima non può certo essere addossata al privato, essendo la sua base imponibile esclusivamente legata al volume d'affari (o al costo del personale) delle attività produttive. Quindi, dal totale pro-capite pagato al Pirellone nelle province lombarde, si dovrà detrarre una quota non inferiore agli ottocento euro (ho utilizzato, per il gettito lombardo, i dati ricavati da un'indagine UIL a preventivo 2005 disponibile qui, rapportato ai nove milioni circa di abitanti nella regione). Restano cioè poco meno di trecento euro di tributi regionali a carico dei lombardi. Ciò che dovrebbe emergere, al contrario, è che, poiché l'IRAP finanzia prevalentemente (e indirettamente) la spesa sanitaria e, sempre prevalentemente, non è carico delle persone fisiche, il dato della Cgia rappresenta non il peso fiscale effettivo, ma quello che dovrebbe essere applicato, in relazione ai servizi offerti. Si tratta di un ragionamento estremamente semplificato, ma che riporta l'oggetto dell'osservazione a un minimo comune denominatore. Di quei trecento euro, infine, un'altra fettina (più o meno sottile) se la porta via la compartecipazione sulle accise del carburante, cioè un tributo in senso stretto, ma affatto legato (come l'IRAP) ai servizi offerti dall'ente Regione. In conclusione, Milano, anche senza il contributo sostanzioso dei tributi regionali, manterrebbe la testa della classifica stilata dalla Cgia (Venezia non fa testo perché, come spiegato nella striminzita legenda, beneficia dei proventi dell'annessa casa da gioco e, si sa, l'azzardo è vizio capitale), ma spiegarne i motivi è tutto un altro paio di maniche.
Dalle parti della Madonnina è tutto un triste rimirar portafogli vuoti, dopo le rivelazioni dell'Ufficio Studi della Cgia di Mestre (che, ricordiamo, non è una ONLUS ma l'associazione di categoria che riunisce piccole imprese e artigiani della zona) secondo le quali il capoluogo lombardo soffre di un eccesso di tributi locali rispetto al resto del territorio nazionale. Il dato nudo e crudo (rilevato da consuntivo 2005), infatti, è piuttosto schietto: a Milano se ne vanno via, ogni anno, in tasse comunali, provinciali e regionali la bellezza di € 2.082,23 a cittadino, contro una media nazionale di € 1.434,13 oppure, tanto per fare un esempio, contro i 1.486,50 euro sborsati dal cittadino di Siena. Il fior fiore della stampa quotidiana nazionale si è gettata a pesce sulla notizia, un po' perché parlar di vil denaro ingolosisce sempre il lettore (invidioso e livoroso al tempo stesso), un po' perché a buon mercato le si offre la sponda per tornare a parlar male di quella casta che spilla risorse dove può, quando può, più che può, e se in classifica arriva prima Milano oppure Enna importa punto. Non che la notizia manchi di un suo specifico allure, specie se, oltre le veline di prammatica, si abbia la pazienza (mica poi tanta) di trovare il documento originale e guardarsi la tabella allegata e riepilogativa. Da cui si ricava, ad esempio, che dell'impressionante dato meneghino è parecchio responsabile l'ente Regione che svetta, sulle venti totali, con i suoi milleottantotto euro per abitante. A onor del vero, in tutta la Lombardia non v'è altro capoluogo che sprema così i propri contribuenti (nell'almeno altrettanto operosa Brescia pagano quasi il 50% in meno all'Amministrazione comunale). Siccome però il can can seguito alla notizia fa leva sul valore assoluto del salasso fiscale, converrà andar più a fondo e, utilizzando semplicemente gli scarni numeri forniti dai veneti, verificarne la consistenza. Osservando l'elenco di città capoluogo che segue alla breve analisi della Cgia, balza subito all'occhio con malinconica evidenza che le province sono davvero l'anello inutile nella catena delle autonomie locali nel quadro istituzionale odierno. Con quegli striminziti ottanta euro annui di pressione fiscale (un decimo del peso regionale) vien quasi voglia di regalargliene qualche altro, salvo ricordarsi immediatamente dell'incontrovertibile assenza di qualsiasi ragione per mantenere in vita l'ente intermedio per eccellenza. Tornando invece alla tenzone che contrappone, in una riedizione moderna dei duelli rusticani, comuni e regioni, si dovrà tener innanzitutto conto di un elemento predominante: l'IRAP. Quest'ultima non può certo essere addossata al privato, essendo la sua base imponibile esclusivamente legata al volume d'affari (o al costo del personale) delle attività produttive. Quindi, dal totale pro-capite pagato al Pirellone nelle province lombarde, si dovrà detrarre una quota non inferiore agli ottocento euro (ho utilizzato, per il gettito lombardo, i dati ricavati da un'indagine UIL a preventivo 2005 disponibile qui, rapportato ai nove milioni circa di abitanti nella regione). Restano cioè poco meno di trecento euro di tributi regionali a carico dei lombardi. Ciò che dovrebbe emergere, al contrario, è che, poiché l'IRAP finanzia prevalentemente (e indirettamente) la spesa sanitaria e, sempre prevalentemente, non è carico delle persone fisiche, il dato della Cgia rappresenta non il peso fiscale effettivo, ma quello che dovrebbe essere applicato, in relazione ai servizi offerti. Si tratta di un ragionamento estremamente semplificato, ma che riporta l'oggetto dell'osservazione a un minimo comune denominatore. Di quei trecento euro, infine, un'altra fettina (più o meno sottile) se la porta via la compartecipazione sulle accise del carburante, cioè un tributo in senso stretto, ma affatto legato (come l'IRAP) ai servizi offerti dall'ente Regione. In conclusione, Milano, anche senza il contributo sostanzioso dei tributi regionali, manterrebbe la testa della classifica stilata dalla Cgia (Venezia non fa testo perché, come spiegato nella striminzita legenda, beneficia dei proventi dell'annessa casa da gioco e, si sa, l'azzardo è vizio capitale), ma spiegarne i motivi è tutto un altro paio di maniche.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 17:45 0 commenti
Categorie: Finanza locale, IRAP, Pressione fiscale locale
venerdì 17 agosto 2007
Sale grosso
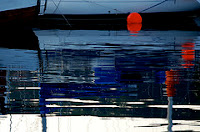 Novanta pagine d'agosto. E' il regalo che ANCI, con il dossier pubblicato da poco sul proprio sito web, fa a tutti gli operatori del personale negli enti locali per fare il punto sulla gestione delle risorse umane fra Patto di stabilità e Finanziaria 2007. In particolare, all'onnivora associazione, interessa soprattutto ribadire il proprio punto di vista sulle numerose ramificazioni della materia che, negli ultimi mesi, hanno subito potature corpose ma anche innesti di rilievo. Converrà leggere attentamente il documento per ripercorrere gli sviluppi normativi e comprendere se le scelte amministrative operate finora sono state in linea con la spesso schizofrenica produzione parlamentare e governativa. Attenzione, però, agli eccessi di confidenza. La nota tendenza di ANCI 'a far parte per se stessa' svela qui un'ulteriore velleità: quella di sentirsi, non solamente autentica e autorevole interprete della lettera normativa, ma, addirittura, legislatore in fieri. Andate a pagina 16 del dossier e immergetevi nel caso dell'ente che, non soggetto al patto di stabilità nel 2007, a seguito di una mobilità verso l'esterno, si trova nella condizione di non sapere con certezza se e con quali limitazioni gli sia possibile colmare il vuoto nella dotazione organica. A dir la verità, la domanda è posta nel più retorico dei modi, quasi imboccando l'esperto di turno (la prossima volta, per dare una parvenza di autenticità a questi quesiti, forse sarà il caso di riscriverli). Ma poco c'importa della forma. Sulla sostanza, invece, si resta davvero di sale. Leggo già nel primo paragrafo: "In riferimento al quesito posto con nota Prot. n. 2958 si fa presente che il comma 562 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha valore integralmente novativo rispetto alla disciplina previgente dettata dal DPCM 15.02.06, che risulta, pertanto, implicitamente abrogato dalla norma in oggetto. E’ dunque, disapplicato anche il comma 8 dell’articolo 5 del DPCM 15.02.06 che, si ricorda, costituiva una norma speciale: l’esclusione della mobilità dal concetto di cessazione derivava, evidentemente, dalla specifica esigenza di raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dallo stesso DPCM ma costituiva una deroga alla natura giuridica della mobilità." Il comma 562 citato riguarda, come ben ricordate, proprio le assunzioni negli enti sotto i 5.000 abitanti: "562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. (quello a tempo determinato. NdR)" Quello che piace dell'ANCI è la disponibilità a prendere il toro per le corna e rassicurare i poco fiduciosi (in generale) enti su questioni che il legislatore si è finora guardato bene dal chiarire. Nel quesito successivo, a riprova di questa coraggiosa vocazione ministeriale, l'ANCI, stuzzicato da un comune fuori Patto che non ha rispettato il limite dell'incremento di spesa dell'1% rispetto al 2004, non teme smentite e mette nero su bianco l'affermazione che: "sarebbe del tutto illogico ed in contraddizione con la nuova ratio delle vigenti norme ritenere ancora valido l’apparato sanzionatorio legato al precedente regime; (...) Si ritiene, dunque, che l’Ente, fermo restando l’obbligo di rispettare il limite di spesa 2004, dettato dal citato comma 562, possa procedere all’assunzione a tempo determinato." Il sollievo che, certo, se ne ricava e che restituisce un minimo di senso logico a un sistema ribaltato annualmente come un calzino dovrà pur essere però temperato da un sano e prudente attendismo. Perché è vero che dai dicasteri competenti non si alza nessuna voce di smentita o di conferma, neppure implicite. Ma se è così lampante che l'apparato sanzionatorio pre-Finanziaria 2007 (il che in sostanza significa blocco del turn-over) non esiste più, perché le Linee guida della Corte dei conti relative ai rendiconti 2006 (pubblicate abbondantemente dopo l'eliminazione delle sanzioni per i Comuni non rispettosi del Patto) continuano a riportare lo specchietto dimostrativo della riduzione dell'1%?
Novanta pagine d'agosto. E' il regalo che ANCI, con il dossier pubblicato da poco sul proprio sito web, fa a tutti gli operatori del personale negli enti locali per fare il punto sulla gestione delle risorse umane fra Patto di stabilità e Finanziaria 2007. In particolare, all'onnivora associazione, interessa soprattutto ribadire il proprio punto di vista sulle numerose ramificazioni della materia che, negli ultimi mesi, hanno subito potature corpose ma anche innesti di rilievo. Converrà leggere attentamente il documento per ripercorrere gli sviluppi normativi e comprendere se le scelte amministrative operate finora sono state in linea con la spesso schizofrenica produzione parlamentare e governativa. Attenzione, però, agli eccessi di confidenza. La nota tendenza di ANCI 'a far parte per se stessa' svela qui un'ulteriore velleità: quella di sentirsi, non solamente autentica e autorevole interprete della lettera normativa, ma, addirittura, legislatore in fieri. Andate a pagina 16 del dossier e immergetevi nel caso dell'ente che, non soggetto al patto di stabilità nel 2007, a seguito di una mobilità verso l'esterno, si trova nella condizione di non sapere con certezza se e con quali limitazioni gli sia possibile colmare il vuoto nella dotazione organica. A dir la verità, la domanda è posta nel più retorico dei modi, quasi imboccando l'esperto di turno (la prossima volta, per dare una parvenza di autenticità a questi quesiti, forse sarà il caso di riscriverli). Ma poco c'importa della forma. Sulla sostanza, invece, si resta davvero di sale. Leggo già nel primo paragrafo: "In riferimento al quesito posto con nota Prot. n. 2958 si fa presente che il comma 562 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha valore integralmente novativo rispetto alla disciplina previgente dettata dal DPCM 15.02.06, che risulta, pertanto, implicitamente abrogato dalla norma in oggetto. E’ dunque, disapplicato anche il comma 8 dell’articolo 5 del DPCM 15.02.06 che, si ricorda, costituiva una norma speciale: l’esclusione della mobilità dal concetto di cessazione derivava, evidentemente, dalla specifica esigenza di raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dallo stesso DPCM ma costituiva una deroga alla natura giuridica della mobilità." Il comma 562 citato riguarda, come ben ricordate, proprio le assunzioni negli enti sotto i 5.000 abitanti: "562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. (quello a tempo determinato. NdR)" Quello che piace dell'ANCI è la disponibilità a prendere il toro per le corna e rassicurare i poco fiduciosi (in generale) enti su questioni che il legislatore si è finora guardato bene dal chiarire. Nel quesito successivo, a riprova di questa coraggiosa vocazione ministeriale, l'ANCI, stuzzicato da un comune fuori Patto che non ha rispettato il limite dell'incremento di spesa dell'1% rispetto al 2004, non teme smentite e mette nero su bianco l'affermazione che: "sarebbe del tutto illogico ed in contraddizione con la nuova ratio delle vigenti norme ritenere ancora valido l’apparato sanzionatorio legato al precedente regime; (...) Si ritiene, dunque, che l’Ente, fermo restando l’obbligo di rispettare il limite di spesa 2004, dettato dal citato comma 562, possa procedere all’assunzione a tempo determinato." Il sollievo che, certo, se ne ricava e che restituisce un minimo di senso logico a un sistema ribaltato annualmente come un calzino dovrà pur essere però temperato da un sano e prudente attendismo. Perché è vero che dai dicasteri competenti non si alza nessuna voce di smentita o di conferma, neppure implicite. Ma se è così lampante che l'apparato sanzionatorio pre-Finanziaria 2007 (il che in sostanza significa blocco del turn-over) non esiste più, perché le Linee guida della Corte dei conti relative ai rendiconti 2006 (pubblicate abbondantemente dopo l'eliminazione delle sanzioni per i Comuni non rispettosi del Patto) continuano a riportare lo specchietto dimostrativo della riduzione dell'1%?
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 21:11 0 commenti
Categorie: ANCI, Finanziaria 2007, Patto di stabilità, Personale, Spese per il personale
giovedì 16 agosto 2007
Testa di ponte
 Il Ministero diretto da TPS (acronimo felicemente introdotto dallo Struzzo giallo) ha appena rilasciato una circolare che dovrebbe fungere da ponte tra una norma introdotta dal D.L. n. 262/2006 e il relativo (ma non ancora emesso) decreto attuativo. Si tratta del nuovo articolo aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sulla riscossione coattiva. Le amministrazioni pubbliche (enti locali e società da loro partecipate compresi) non possono procedere a pagamenti per importi uguali o superiori a diecimila euro se il creditore è contemporaneamente debitore dell'erario per almeno analogo ammontare (certificato da cartelle esattoriali già notificate). In un sistema di produzione normativa come il nostro dove la gerarchia delle fonti scricchiola troppo spesso (la vicenda ancor tiepida dei rinvii di scadenze fiscali adottati con comunicato stampa ne è sufficiente esempio), le otto pagine prodotte sul tema rappresentano un ulteriore sviluppo: la circolare-decreto. Concettualmente siamo abituati a una sequenza cronologica che dalla norma (da regolamentare) porta al decreto (che regolamenta) e, infine, a una o più circolari (che ne spiegano eventualmente la portata, essendo sempre possibile, se non auspicabile, che il provvedimento attuativo sia, in sè, sufficientemente chiaro ed esaustivo). Invertendo i fattori, il Ministero qui prova ad ottenere l'identico risultato, ma incappa in un paio (almeno) di svarioni. Mettendo le mani avanti, con un trucchetto ormai obsoleto, la Ragioneria generale dello Stato prova subito a far sentire in colpa il destinatario lettore premettendo che, regolamento o no, la norma introdotta è immediatamente cogente. Dunque, guai a chi non si adegua seduta stante, anche perché in immediato soccorso giunge opportuna la Sezione per la Basilicata della Corte dei conti che già nello scorso maggio aveva affermato che il provvedimento: "non incide sull’an dell’applicazione, ma è deputato solo a specificarne il quomodo (le modalità di attuazione). Si noti, peraltro, che il primo comma in esame individua precisamente i soggetti obbligati (le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica), il presupposto (l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento per un importo pari almeno a € 10.000) e le conseguenze previste (blocco del pagamento e segnalazione della circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo), limitandosi però a prevedere una non meglio individuata attività di verifica, anche telematica, dell’esistenza del predetto presupposto. L’emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata." Nella circolare, tuttavia, si omette di riportare il periodo immediatamente successivo del parere lucano: "Non è chi non veda, però, che, in attesa dell’emanazione del previsto regolamento, sussistono delle sicure difficoltà oggettive per la concreta esecuzione della norma.
Il Ministero diretto da TPS (acronimo felicemente introdotto dallo Struzzo giallo) ha appena rilasciato una circolare che dovrebbe fungere da ponte tra una norma introdotta dal D.L. n. 262/2006 e il relativo (ma non ancora emesso) decreto attuativo. Si tratta del nuovo articolo aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sulla riscossione coattiva. Le amministrazioni pubbliche (enti locali e società da loro partecipate compresi) non possono procedere a pagamenti per importi uguali o superiori a diecimila euro se il creditore è contemporaneamente debitore dell'erario per almeno analogo ammontare (certificato da cartelle esattoriali già notificate). In un sistema di produzione normativa come il nostro dove la gerarchia delle fonti scricchiola troppo spesso (la vicenda ancor tiepida dei rinvii di scadenze fiscali adottati con comunicato stampa ne è sufficiente esempio), le otto pagine prodotte sul tema rappresentano un ulteriore sviluppo: la circolare-decreto. Concettualmente siamo abituati a una sequenza cronologica che dalla norma (da regolamentare) porta al decreto (che regolamenta) e, infine, a una o più circolari (che ne spiegano eventualmente la portata, essendo sempre possibile, se non auspicabile, che il provvedimento attuativo sia, in sè, sufficientemente chiaro ed esaustivo). Invertendo i fattori, il Ministero qui prova ad ottenere l'identico risultato, ma incappa in un paio (almeno) di svarioni. Mettendo le mani avanti, con un trucchetto ormai obsoleto, la Ragioneria generale dello Stato prova subito a far sentire in colpa il destinatario lettore premettendo che, regolamento o no, la norma introdotta è immediatamente cogente. Dunque, guai a chi non si adegua seduta stante, anche perché in immediato soccorso giunge opportuna la Sezione per la Basilicata della Corte dei conti che già nello scorso maggio aveva affermato che il provvedimento: "non incide sull’an dell’applicazione, ma è deputato solo a specificarne il quomodo (le modalità di attuazione). Si noti, peraltro, che il primo comma in esame individua precisamente i soggetti obbligati (le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica), il presupposto (l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento per un importo pari almeno a € 10.000) e le conseguenze previste (blocco del pagamento e segnalazione della circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo), limitandosi però a prevedere una non meglio individuata attività di verifica, anche telematica, dell’esistenza del predetto presupposto. L’emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata." Nella circolare, tuttavia, si omette di riportare il periodo immediatamente successivo del parere lucano: "Non è chi non veda, però, che, in attesa dell’emanazione del previsto regolamento, sussistono delle sicure difficoltà oggettive per la concreta esecuzione della norma.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 15:52 2 commenti
Categorie: Cartella esattoriale, Pagamenti
mercoledì 15 agosto 2007
Fave e piccioni
 Un breve intervento di Antonino Borghi sul Lenzuolo rosa di lunedì 6 agosto (analoghi argomenti sono stati usati di recente anche da Stefano Pozzoli sulle stesse colonne) ci ricorda, con lucida sinteticità, che il problema della valutazione delle prestazioni non potrà mai risolversi senza modificarne il vizio originale: la cronica mancanza di obiettivi verificabili nella programmazione degli enti. Lo si può riscontrare ordinariamente nelle strutture piccole come in quelle grandi, senza soluzione di continuità, e denota un enorme buco organizzativo in processi regolati minuziosamente da leggi e contratti collettivi ma affatto applicati. Ciò vale per i dirigenti ma si può tranquillamente estendere anche a chi non ha responsabilità di risultato e che, in ogni caso, deve essere valutato per ottenere una quota del fondo di produttività. Siccome l'esterofilia è virus fuori moda, ricorderemo sottovoce che quanto accade, ad esempio, nei paesi anglosassoni qui non è neppure lontanamente realizzabile, eppure è l'esempio a cui fare adeguato riferimento. L'approvazione del documento analogo al nostro bilancio di previsione è l'occasione da quelle parti per fissare un rigidissimo elenco di obiettivi applicato a ciascun settore di intervento (finanziario certo, ma anche manutentivo, sociale, culturale). La rigidità (nel senso di non contrattabilità a posteriori) non è certo a scapito della chiarezza, perché questi obiettivi sono tutti, invariabilmente, misurabili. Quest'ultima caratteristica è esattamente il buco di cui si diceva prima. Fin dall'inizio, chi ha responsabilità di risultato sa che al termine dell'esercizio quello è il benchmark in base al quale sarà valutato. Poiché gli obiettivi non sono campati per aria, ma fissati sulla base di un adeguato confronto con dati nazionali e locali, non è pensabile che, chiuso l'esercizio, il dirigente possa giustificare un eventuale insuccesso con l'irraggiungibilità della meta. In questa situazione, viene quasi da chiedersi a cosa serva un nucleo di valutazione se non a certificare semplicemente l'esito finale di un anno di gestione, senza ulteriori elaborazioni. Dunque, perché negli enti italiani non è possibile adottare un sistema del genere? La risposta, secondo Borghi, sta nella poco diffusa applicazione della contabilità economica, molto più adatta a misurare (anche in corso d'anno) gli scostamenti dall'obiettivo fissato inizialmente. La premessa è l'abbandono progressivo ma inevitabile della contabilità finanziaria. Poiché non è pensabile che la contabilità degli enti locali sia gestita con un sistema diverso da quello adottato per lo Stato, resta il fortissimo sospetto che, a dispetto di ogni buona intenzione, nessuno, a livello centrale, voglia disfarsi di uno strumento che ha finora garantito il lussuoso funzionamento delle istituzioni.
Un breve intervento di Antonino Borghi sul Lenzuolo rosa di lunedì 6 agosto (analoghi argomenti sono stati usati di recente anche da Stefano Pozzoli sulle stesse colonne) ci ricorda, con lucida sinteticità, che il problema della valutazione delle prestazioni non potrà mai risolversi senza modificarne il vizio originale: la cronica mancanza di obiettivi verificabili nella programmazione degli enti. Lo si può riscontrare ordinariamente nelle strutture piccole come in quelle grandi, senza soluzione di continuità, e denota un enorme buco organizzativo in processi regolati minuziosamente da leggi e contratti collettivi ma affatto applicati. Ciò vale per i dirigenti ma si può tranquillamente estendere anche a chi non ha responsabilità di risultato e che, in ogni caso, deve essere valutato per ottenere una quota del fondo di produttività. Siccome l'esterofilia è virus fuori moda, ricorderemo sottovoce che quanto accade, ad esempio, nei paesi anglosassoni qui non è neppure lontanamente realizzabile, eppure è l'esempio a cui fare adeguato riferimento. L'approvazione del documento analogo al nostro bilancio di previsione è l'occasione da quelle parti per fissare un rigidissimo elenco di obiettivi applicato a ciascun settore di intervento (finanziario certo, ma anche manutentivo, sociale, culturale). La rigidità (nel senso di non contrattabilità a posteriori) non è certo a scapito della chiarezza, perché questi obiettivi sono tutti, invariabilmente, misurabili. Quest'ultima caratteristica è esattamente il buco di cui si diceva prima. Fin dall'inizio, chi ha responsabilità di risultato sa che al termine dell'esercizio quello è il benchmark in base al quale sarà valutato. Poiché gli obiettivi non sono campati per aria, ma fissati sulla base di un adeguato confronto con dati nazionali e locali, non è pensabile che, chiuso l'esercizio, il dirigente possa giustificare un eventuale insuccesso con l'irraggiungibilità della meta. In questa situazione, viene quasi da chiedersi a cosa serva un nucleo di valutazione se non a certificare semplicemente l'esito finale di un anno di gestione, senza ulteriori elaborazioni. Dunque, perché negli enti italiani non è possibile adottare un sistema del genere? La risposta, secondo Borghi, sta nella poco diffusa applicazione della contabilità economica, molto più adatta a misurare (anche in corso d'anno) gli scostamenti dall'obiettivo fissato inizialmente. La premessa è l'abbandono progressivo ma inevitabile della contabilità finanziaria. Poiché non è pensabile che la contabilità degli enti locali sia gestita con un sistema diverso da quello adottato per lo Stato, resta il fortissimo sospetto che, a dispetto di ogni buona intenzione, nessuno, a livello centrale, voglia disfarsi di uno strumento che ha finora garantito il lussuoso funzionamento delle istituzioni.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 15:38 0 commenti
Categorie: Contabilità economica, Nucleo di valutazione
martedì 14 agosto 2007
Incolonnati
 Ho letto domenica con la consueta curiosità il quindicinale pezzo di Enrico De Mita sul Lenzuolo rosa e, lo confesso, non l'ho capito. Non ne ho compreso, cioè, la tesi sottostante. L'argomento era di quelli sapidi, da alimentare dibattiti e discussioni per mesi, da qui alla prossima primavera: il progetto di legge delega sul federalismo fiscale, approvato dal Governo il 3 agosto, ora in attesa della discussione parlamentare. Il titolo del pezzo era promettente: "Federalismo: legge delega debole e incerta". Finalmente, ho pensato, un rigoroso e stentoreo contributo a favore di una revisione del testo in prospettiva davvero decentralizzata. Invece, a parte alcune osservazioni che meritano di essere commentate, non vi ho trovato una tesi unitaria (da condividere o respingere); piuttosto, dopo un assaggio di analisi critica, una rapida e incomprensibile interruzione del ragionamento, quasi in redazione avessero voluto tagliar corto una volta riempite le due colonne assegnate. La premessa è, appunto, il via libera di Palazzo Chigi a un provvedimento che deve dare attuazione al testo nuovo dell'art. 119 della Costituzione sul finanziamento delle autonomie locali. Di certo, oggi, si sa che, dopo l'approvazione parlamentare e il passaggio in Conferenza Unificata per acquisire il parere di Regioni, Province e Comuni, entro i successivi 12 mesi l'esecutivo dovrà approvare uno o più decreti legislativi che daranno contenuto all'involucro adottato. Giusta, qui, la critica di De Mita alla scelta di utilizzare lo strumento della delega legislativa che, in materia costituzionale, dovrebbe essere accantonato per un più ampio dibattito parlamentare sfociante in una legge ordinaria. A seguire, il professore suddivide il provvedimento in due porzioni distinte. La prima che si incarica di costruire l'impalcatura del sistema fiscale locale prossimo venturo, con il suo mix di poteri impositivi assegnati alle Regioni e agli altri enti locali (articolo 3). La seconda che, in realtà, altro non è se non una mera previsione di maggiore gettito agli enti locali a seguito dell'assegnazione di quote di tributi ora 'statali'. A parte quest'ultima, poco interessante, ciò di cui serve occuparsi è la porzione autonomista. E infatti De Mita ne sottolinea la delicatezza, in particolare quando all'art. 3, c. 1, lett. g) si legge: "1. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi: (...) g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a): 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell’esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od agevolazioni;". Rispetto all'attuale sistema, il DDL introduce un passaggio intermedio che formalmente assegna alle Regioni il ruolo che oggi è della legge statale. La qualità dei decreti attuativi si misurerà sull'equilibrio che essi sapranno offrire delle potestà attribuite parallelamente alle regioni e a tutti gli altri enti. Maggiore libertà di azione ai comuni non può in ogni caso significare, infatti, il ritorno a un fisco feudale che moltiplica all'infinito i tributi a dispetto della chiarezza e della semplificazione. Su questo passaggio peraltro, al contrario di De Mita, non vedo quale altro strumento abbiano i comuni per "stabilire tributi locali" se non un regolamento consiliare. Tra l'altro, non credo neppure che la norma delegante intenda attribuire alle municipalità una potestà impositiva che non sia compresa all'interno di un quadro tassativamente predefinito dalle Regioni (e tra le Regioni coordinato), altrimenti perché sarebbe così esplicito il richiamo alla "previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione."? Poco oltre, De Mita osserva: "Se il sistema tributario deve essere razionale nel suo complesso (il che sembra ovvio) e coerente (e qui la cosa diventa alquanto più opinabile)...". In che senso "opinabile"? Che il sistema non deve essere coerente, a scapito dell'autonomia degli enti? Oppure che è materialmente impossibile arrivare a un sistema coerente, causa insostenibili pressioni politiche? A proposito, l'autore nulla dice lasciando il dubbio che la sua opinione penda più verso quest'ultima interpretazione. Lo stesso Lenzuolo, il lunedì precedente, aveva aperto ricordando che il prelievo fiscale delle Regioni nel 2007 è cresciuto del 5,4% rispetto all'anno precedente, aumentando il sospetto che la coerenza è già realtà, solo se si tratta di ritoccare le aliquote per ripianare i deficit del settore sanitario, però. La preoccupazione del professore è rivolta al diffondersi della doppia imposizione, soprattutto in tema di imposizione sui redditi, sottolineando la complessità di un impianto normativo che distribuisce potestà ai diversi livelli, senza definirne con esattezza i confini. Detto questo, tuttavia, De Mita si ferma. In pratica, un terzo abbondante del pezzo (tutta la parte finale) è dedicato alla pedissequa riproduzione dei tributi di competenza regionale, provinciale e comunale. Quale dovrebbe essere dunque la conclusione del ragionamento? O meglio, come vorremmo che fosse il sistema tributario dopo il decentramento? La mia opinione personale è che il peso delle Regioni dovrebbe essere ridimensionato, a favore di una maggiore uniformità del prelievo sul territorio nazionale, individuando nella legge dello Stato l'unica fonte di istituzione tributaria e indicando tassativamente quali sono i tributi applicabili da Province e Comuni e la relativa base imponibile. L'autonomia locale sarebbe poi garantita lasciando agli enti la libertà di stabilire aliquote, detrazioni e agevolazioni per meglio rispondere alle esigenze della singola comunità amministrata. Razionale (perché nessuno potrebbe inventarsi nuovi balzelli) e coerente (perché riferito a norme giuridiche in vigore erga omnes).
Ho letto domenica con la consueta curiosità il quindicinale pezzo di Enrico De Mita sul Lenzuolo rosa e, lo confesso, non l'ho capito. Non ne ho compreso, cioè, la tesi sottostante. L'argomento era di quelli sapidi, da alimentare dibattiti e discussioni per mesi, da qui alla prossima primavera: il progetto di legge delega sul federalismo fiscale, approvato dal Governo il 3 agosto, ora in attesa della discussione parlamentare. Il titolo del pezzo era promettente: "Federalismo: legge delega debole e incerta". Finalmente, ho pensato, un rigoroso e stentoreo contributo a favore di una revisione del testo in prospettiva davvero decentralizzata. Invece, a parte alcune osservazioni che meritano di essere commentate, non vi ho trovato una tesi unitaria (da condividere o respingere); piuttosto, dopo un assaggio di analisi critica, una rapida e incomprensibile interruzione del ragionamento, quasi in redazione avessero voluto tagliar corto una volta riempite le due colonne assegnate. La premessa è, appunto, il via libera di Palazzo Chigi a un provvedimento che deve dare attuazione al testo nuovo dell'art. 119 della Costituzione sul finanziamento delle autonomie locali. Di certo, oggi, si sa che, dopo l'approvazione parlamentare e il passaggio in Conferenza Unificata per acquisire il parere di Regioni, Province e Comuni, entro i successivi 12 mesi l'esecutivo dovrà approvare uno o più decreti legislativi che daranno contenuto all'involucro adottato. Giusta, qui, la critica di De Mita alla scelta di utilizzare lo strumento della delega legislativa che, in materia costituzionale, dovrebbe essere accantonato per un più ampio dibattito parlamentare sfociante in una legge ordinaria. A seguire, il professore suddivide il provvedimento in due porzioni distinte. La prima che si incarica di costruire l'impalcatura del sistema fiscale locale prossimo venturo, con il suo mix di poteri impositivi assegnati alle Regioni e agli altri enti locali (articolo 3). La seconda che, in realtà, altro non è se non una mera previsione di maggiore gettito agli enti locali a seguito dell'assegnazione di quote di tributi ora 'statali'. A parte quest'ultima, poco interessante, ciò di cui serve occuparsi è la porzione autonomista. E infatti De Mita ne sottolinea la delicatezza, in particolare quando all'art. 3, c. 1, lett. g) si legge: "1. Ai fini del coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi: (...) g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a): 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le materie nelle quali comuni, province e città metropolitane possono, nell’esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali, introdurre variazioni alle aliquote od agevolazioni;". Rispetto all'attuale sistema, il DDL introduce un passaggio intermedio che formalmente assegna alle Regioni il ruolo che oggi è della legge statale. La qualità dei decreti attuativi si misurerà sull'equilibrio che essi sapranno offrire delle potestà attribuite parallelamente alle regioni e a tutti gli altri enti. Maggiore libertà di azione ai comuni non può in ogni caso significare, infatti, il ritorno a un fisco feudale che moltiplica all'infinito i tributi a dispetto della chiarezza e della semplificazione. Su questo passaggio peraltro, al contrario di De Mita, non vedo quale altro strumento abbiano i comuni per "stabilire tributi locali" se non un regolamento consiliare. Tra l'altro, non credo neppure che la norma delegante intenda attribuire alle municipalità una potestà impositiva che non sia compresa all'interno di un quadro tassativamente predefinito dalle Regioni (e tra le Regioni coordinato), altrimenti perché sarebbe così esplicito il richiamo alla "previsione che la disciplina dei singoli tributi ed il sistema tributario nel suo complesso debbano rispondere a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati ed accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione."? Poco oltre, De Mita osserva: "Se il sistema tributario deve essere razionale nel suo complesso (il che sembra ovvio) e coerente (e qui la cosa diventa alquanto più opinabile)...". In che senso "opinabile"? Che il sistema non deve essere coerente, a scapito dell'autonomia degli enti? Oppure che è materialmente impossibile arrivare a un sistema coerente, causa insostenibili pressioni politiche? A proposito, l'autore nulla dice lasciando il dubbio che la sua opinione penda più verso quest'ultima interpretazione. Lo stesso Lenzuolo, il lunedì precedente, aveva aperto ricordando che il prelievo fiscale delle Regioni nel 2007 è cresciuto del 5,4% rispetto all'anno precedente, aumentando il sospetto che la coerenza è già realtà, solo se si tratta di ritoccare le aliquote per ripianare i deficit del settore sanitario, però. La preoccupazione del professore è rivolta al diffondersi della doppia imposizione, soprattutto in tema di imposizione sui redditi, sottolineando la complessità di un impianto normativo che distribuisce potestà ai diversi livelli, senza definirne con esattezza i confini. Detto questo, tuttavia, De Mita si ferma. In pratica, un terzo abbondante del pezzo (tutta la parte finale) è dedicato alla pedissequa riproduzione dei tributi di competenza regionale, provinciale e comunale. Quale dovrebbe essere dunque la conclusione del ragionamento? O meglio, come vorremmo che fosse il sistema tributario dopo il decentramento? La mia opinione personale è che il peso delle Regioni dovrebbe essere ridimensionato, a favore di una maggiore uniformità del prelievo sul territorio nazionale, individuando nella legge dello Stato l'unica fonte di istituzione tributaria e indicando tassativamente quali sono i tributi applicabili da Province e Comuni e la relativa base imponibile. L'autonomia locale sarebbe poi garantita lasciando agli enti la libertà di stabilire aliquote, detrazioni e agevolazioni per meglio rispondere alle esigenze della singola comunità amministrata. Razionale (perché nessuno potrebbe inventarsi nuovi balzelli) e coerente (perché riferito a norme giuridiche in vigore erga omnes).
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 15:04 0 commenti
Categorie: Federalismo fiscale, Tributi locali
lunedì 13 agosto 2007
Autostrada 61
 Se se ne accorge il Lenzuolo rosa, è proprio vero. Quando la maggior parte degli osservatori sta in vacanza (suppongo), è il momento più opportuno per ricordare alla platea di lettori che i Ministeri, quando si tratta di chiedere dati ai Comuni, rifiutano qualsiasi tentativo di semplificazione e, troppo spesso, raddoppiano. E' passato appena un mese da quando, modestamente, su queste pagine si faceva rilevare l'assurdità di moltiplicare inutilmente gli invii di dati riguardanti il personale (cfr. La quarta corsia), onerosi (in termini di tempo e risorse impiegati) e beffardi (perché indirizzati a dicasteri differenti ma, evidentemente, tutt'altro che comunicanti). Stamane il Lenzuolo ripropone il tema, con l'autorevolezza della fonte professionale, utilizzando argomentazioni che, appunto, sottoscriviamo interamente. Peraltro, la duplicazione di cui si parla non è affatto una novità, come sembrerebbe ritenere Patrizia Ruffini. Il Censimento del Ministero dell'Interno, ricorderete, fu effettuato già una prima volta nel 2001, per certificare la situazione al 31 dicembre 2000, e non era neppure telematico. Fu ripetuto, in assenza di una specifica prescrizione periodica, nell'estate del 2004 con riferimento agli organici del 1° gennaio 2004. Siamo quindi alla terza rilevazione statistica ai sensi dell'art. 98 del TUEL. Ciò non toglie che il problema rimanga, in tutta la sua involontaria comicità. C'è, in questa insistenza ministeriale, tutta la protervia della burocrazia che si rifiuta di venire a patti con un livello decente di efficienza. Cosa mai potrà impedire agli Interni di coordinarsi con il Tesoro e integrare il proprio censimento con quello (ben più ricco di notizie) realizzato attraverso la piattaforma SICO? Non potrebbe essere accettata la scusa che i due adempimenti non hanno uguale cadenza: variabile (checché ne dica il Lenzuolo) per il CEPEL, annuale per il SICO. Basterebbe, infatti, che la prima si uniformasse alla seconda e non si creerebbero ulteriori sovrapposizioni. Ancor peggio sarebbe se si accampasse l'alibi della differente prescrizione legislativa (il TUEL vs. il D.Lgs. 165/2001), visto che le norme non si autoapprovano, dunque possono in ogni momento (e legislatura) essere fra loro coordinate. Che l'esigenza, poi, di ottenere informazioni puntuali e periodiche sia primaria è indiscutibile. Ma allora perché il CEPEL sparisce per anni, salvo spuntare quando qualcuno si desta dal letargo informatico? La beffa non si esaurisce qui, naturalmente. Poiché, come giustamente mette in rilievo il Lenzuolo, il censimento CEPEL chiede dati che gli enti devono inviare con i certificati al bilancio e al rendiconto (i quali sono inviati, udite udite, allo stesso Ministero dell'Interno). Forse il problema qui sta nel fatto che i certificati sono inviati a un dipartimento diverso: si sa, è meglio non urtare la suscettibilità di qualche dirigente puntuto... L'effetto perverso che continuiamo a non comprendere e che dà all'intera vicenda il gusto della commedia dell'arte è quello per il quale i dati sono inghiottiti dal potente sistema informativo centrale in tempi rapidi ma dallo stesso vengono digeriti con una lentezza che non ha ragioni. Così, l'elaborazione completa dei dati di un anno possiamo consultarla solo dopo due anni, se siamo fortunati. Ora non resta che compilare le schede e passare oltre, perché purtroppo nessun lamento sarà mai ascoltato. In questa vicenda, infatti, c'è la palese complicità delle associazioni di categoria: già nel 2004, in una nota a corredo, il Ministero precisava che: "Le domande contenute nel nuovo censimento formano una tabella che è stata aggiornata sulla base delle disposizioni contrattuali nel frattempo intervenute, in modo da consentire una lettura della situazione esistente al fine di facilitare gli eventuali interventi legislativi. Le domande sono state elaborate d’intesa con le associazioni istituzionali degli Enti locali." Lascio per ultima la vera chicca, degna di Groucho Marx: "Il terzo elemento di novità è costituito dalla previsione di un’utilizzazione esclusiva delle opportunità offerte dalla rete internet, cosicché sarà questo il primo censimento telematico. Una specifica pagina web è infatti stata costruita all’interno del sito del ministero dell’Interno ed essa permette di scaricare direttamente sul proprio computer il programma necessario per dare risposta alle richieste del censimento."
Se se ne accorge il Lenzuolo rosa, è proprio vero. Quando la maggior parte degli osservatori sta in vacanza (suppongo), è il momento più opportuno per ricordare alla platea di lettori che i Ministeri, quando si tratta di chiedere dati ai Comuni, rifiutano qualsiasi tentativo di semplificazione e, troppo spesso, raddoppiano. E' passato appena un mese da quando, modestamente, su queste pagine si faceva rilevare l'assurdità di moltiplicare inutilmente gli invii di dati riguardanti il personale (cfr. La quarta corsia), onerosi (in termini di tempo e risorse impiegati) e beffardi (perché indirizzati a dicasteri differenti ma, evidentemente, tutt'altro che comunicanti). Stamane il Lenzuolo ripropone il tema, con l'autorevolezza della fonte professionale, utilizzando argomentazioni che, appunto, sottoscriviamo interamente. Peraltro, la duplicazione di cui si parla non è affatto una novità, come sembrerebbe ritenere Patrizia Ruffini. Il Censimento del Ministero dell'Interno, ricorderete, fu effettuato già una prima volta nel 2001, per certificare la situazione al 31 dicembre 2000, e non era neppure telematico. Fu ripetuto, in assenza di una specifica prescrizione periodica, nell'estate del 2004 con riferimento agli organici del 1° gennaio 2004. Siamo quindi alla terza rilevazione statistica ai sensi dell'art. 98 del TUEL. Ciò non toglie che il problema rimanga, in tutta la sua involontaria comicità. C'è, in questa insistenza ministeriale, tutta la protervia della burocrazia che si rifiuta di venire a patti con un livello decente di efficienza. Cosa mai potrà impedire agli Interni di coordinarsi con il Tesoro e integrare il proprio censimento con quello (ben più ricco di notizie) realizzato attraverso la piattaforma SICO? Non potrebbe essere accettata la scusa che i due adempimenti non hanno uguale cadenza: variabile (checché ne dica il Lenzuolo) per il CEPEL, annuale per il SICO. Basterebbe, infatti, che la prima si uniformasse alla seconda e non si creerebbero ulteriori sovrapposizioni. Ancor peggio sarebbe se si accampasse l'alibi della differente prescrizione legislativa (il TUEL vs. il D.Lgs. 165/2001), visto che le norme non si autoapprovano, dunque possono in ogni momento (e legislatura) essere fra loro coordinate. Che l'esigenza, poi, di ottenere informazioni puntuali e periodiche sia primaria è indiscutibile. Ma allora perché il CEPEL sparisce per anni, salvo spuntare quando qualcuno si desta dal letargo informatico? La beffa non si esaurisce qui, naturalmente. Poiché, come giustamente mette in rilievo il Lenzuolo, il censimento CEPEL chiede dati che gli enti devono inviare con i certificati al bilancio e al rendiconto (i quali sono inviati, udite udite, allo stesso Ministero dell'Interno). Forse il problema qui sta nel fatto che i certificati sono inviati a un dipartimento diverso: si sa, è meglio non urtare la suscettibilità di qualche dirigente puntuto... L'effetto perverso che continuiamo a non comprendere e che dà all'intera vicenda il gusto della commedia dell'arte è quello per il quale i dati sono inghiottiti dal potente sistema informativo centrale in tempi rapidi ma dallo stesso vengono digeriti con una lentezza che non ha ragioni. Così, l'elaborazione completa dei dati di un anno possiamo consultarla solo dopo due anni, se siamo fortunati. Ora non resta che compilare le schede e passare oltre, perché purtroppo nessun lamento sarà mai ascoltato. In questa vicenda, infatti, c'è la palese complicità delle associazioni di categoria: già nel 2004, in una nota a corredo, il Ministero precisava che: "Le domande contenute nel nuovo censimento formano una tabella che è stata aggiornata sulla base delle disposizioni contrattuali nel frattempo intervenute, in modo da consentire una lettura della situazione esistente al fine di facilitare gli eventuali interventi legislativi. Le domande sono state elaborate d’intesa con le associazioni istituzionali degli Enti locali." Lascio per ultima la vera chicca, degna di Groucho Marx: "Il terzo elemento di novità è costituito dalla previsione di un’utilizzazione esclusiva delle opportunità offerte dalla rete internet, cosicché sarà questo il primo censimento telematico. Una specifica pagina web è infatti stata costruita all’interno del sito del ministero dell’Interno ed essa permette di scaricare direttamente sul proprio computer il programma necessario per dare risposta alle richieste del censimento."
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 15:30 0 commenti
Categorie: Censimento generale del personale 2007, CEPEL
venerdì 3 agosto 2007
L'ultimo banco
 E' difficile, oggi, contestare il ruolo preminente che la Corte dei conti sta assumendo all'interno del quadro istituzionale dei controlli sugli enti locali. La capacità di valutazione dell'andamento gestionale e l'attenzione alla corretta approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti sono appannaggio di un gruppo esteso di professionisti che possono incidere anche profondamente nelle procedure un po' vetuste e non sempre limpide delle amministrazioni comunali. Su alcuni specifici argomenti, però, la completa rigidità di approccio della Corte rischia di ridurne il carisma, alimentandone invece la fama di spauracchio contabile. Lo Struzzo giallo riporta oggi un parere della sezione sarda della Corte che affronta il tema ma fuori moda degli incarichi professionali e dei corrispondenti impegni di spesa. Il caso, frequentissimo, è quello dell'affidamento a un legale dell'incarico di difesa dell'ente in una causa. Per la Corte, che pur riconosce la difficoltà di determinare da subito il corretto importo da impegnare, non sussiste l'impossibilità di quantificare il compenso o, se non altro, di avvicinarvisi con buona approssimazione. Il che comporterebbe la collaborazione del professionista, il quale dovrebbe rilasciare un preventivo circostanziato e dunque non lontano dalla cifra finale. Qui finisce lo spirito collaborativo e inizia il controllo giurisdizionale. Perché qualsiasi somma al di sopra di quanto impegnato, sostiene la Corte, è debito fuori bilancio e dunque da sottoporre al Consiglio per il riconoscimento. Se ne deduce che le alternative possibili sono le seguenti: a) il Comune potrebbe impegnare una somma manifestamente eccessiva, pur di essere certo di non incappare nel debito fuori bilancio. Ma non può, perché commetterebbe un palese illecito amministrativo. b) il Comune impegna la somma preventivata dal professionista. Ma si ritroverà quasi certamente con un debito fuori bilancio, perché la durata e l'esito di una causa non sono di certo predeterminabili. Siccome la posizione della Corte è chiara: "l'impossibilità o la difficoltà di determinare l'esatto ammontare di una spesa non esime dall'obbligo di effettuarne una stima quanto più possibile veritiera e prudenziale, al fine di una corretta imputazione a bilancio", la seconda alternativa è l'unica praticabile. Mi chiedo però se questa insistenza sulla necessità di prevedere esattamente l'ammontare della parcella non rappresenti una forzatura procedurale. Sono consapevole della portata non emendabile della norma e dunque se il conto finale è 100 contro un impegno di 90, quel 10 deve essere riconosciuto in Consiglio. Ma nell'agitare lo spettro del debito fuori bilancio in casi come questo dove in realtà non si è verificata alcuna irregolarità dolosa o colposa, la Corte assomiglia parecchio al secchione che, per spiegare un canto dell'Inferno, lo cita a memoria davanti a tutta la classe.
E' difficile, oggi, contestare il ruolo preminente che la Corte dei conti sta assumendo all'interno del quadro istituzionale dei controlli sugli enti locali. La capacità di valutazione dell'andamento gestionale e l'attenzione alla corretta approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti sono appannaggio di un gruppo esteso di professionisti che possono incidere anche profondamente nelle procedure un po' vetuste e non sempre limpide delle amministrazioni comunali. Su alcuni specifici argomenti, però, la completa rigidità di approccio della Corte rischia di ridurne il carisma, alimentandone invece la fama di spauracchio contabile. Lo Struzzo giallo riporta oggi un parere della sezione sarda della Corte che affronta il tema ma fuori moda degli incarichi professionali e dei corrispondenti impegni di spesa. Il caso, frequentissimo, è quello dell'affidamento a un legale dell'incarico di difesa dell'ente in una causa. Per la Corte, che pur riconosce la difficoltà di determinare da subito il corretto importo da impegnare, non sussiste l'impossibilità di quantificare il compenso o, se non altro, di avvicinarvisi con buona approssimazione. Il che comporterebbe la collaborazione del professionista, il quale dovrebbe rilasciare un preventivo circostanziato e dunque non lontano dalla cifra finale. Qui finisce lo spirito collaborativo e inizia il controllo giurisdizionale. Perché qualsiasi somma al di sopra di quanto impegnato, sostiene la Corte, è debito fuori bilancio e dunque da sottoporre al Consiglio per il riconoscimento. Se ne deduce che le alternative possibili sono le seguenti: a) il Comune potrebbe impegnare una somma manifestamente eccessiva, pur di essere certo di non incappare nel debito fuori bilancio. Ma non può, perché commetterebbe un palese illecito amministrativo. b) il Comune impegna la somma preventivata dal professionista. Ma si ritroverà quasi certamente con un debito fuori bilancio, perché la durata e l'esito di una causa non sono di certo predeterminabili. Siccome la posizione della Corte è chiara: "l'impossibilità o la difficoltà di determinare l'esatto ammontare di una spesa non esime dall'obbligo di effettuarne una stima quanto più possibile veritiera e prudenziale, al fine di una corretta imputazione a bilancio", la seconda alternativa è l'unica praticabile. Mi chiedo però se questa insistenza sulla necessità di prevedere esattamente l'ammontare della parcella non rappresenti una forzatura procedurale. Sono consapevole della portata non emendabile della norma e dunque se il conto finale è 100 contro un impegno di 90, quel 10 deve essere riconosciuto in Consiglio. Ma nell'agitare lo spettro del debito fuori bilancio in casi come questo dove in realtà non si è verificata alcuna irregolarità dolosa o colposa, la Corte assomiglia parecchio al secchione che, per spiegare un canto dell'Inferno, lo cita a memoria davanti a tutta la classe.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 16:33 0 commenti
Categorie: Corte dei conti, Impegno di spesa, Incarichi professionali
giovedì 2 agosto 2007
Buone feste
 Qualcuno comincia a credere sul serio che quest'anno l'approvazione della Legge Finanziaria sarà drasticamente precoce, talché il termine per la deliberazione consiliare del Bilancio di previsione non sarà prorogato e si saluterà il nuovo anno, per la prima volta dopo tempo immemore, senza bisogno di esercizio provvisorio (o peggio, di gestione provvisoria). Questo convincimento nascerebbe da quanto indicato in una risoluzione della Camera dei deputati che, tra le altre cose, si incentra proprio su questo felice proposito. In sostanza, la manovra dovrebbe giungere a rapida conclusione poiché, oltre a essere costituita da un "numero limitato di articoli omogenei, tutti rigorosamente corrispondenti al loro contenuto tipico, evitando l'inserimento di norme meramente ordinamentali, ovvero di carattere localistico o microsettoriale.", sarà (pare) estremamente difficile per l'esecutivo proporre emendamenti al testo una volta giunto in aula per la votazione. Sul punto della riduzione degli articoli vien da sorridere, pensando a quante leggi di bilancio hanno racchiuso in un unico clamoroso blocco cornucopie di provvedimenti frammentati in centinaia (o migliaia, talvolta) di commi. Se non altro, qui si sostiene che ci dovrà essere omogeneità nel contenuto dei singoli articoli, ma aspetterei prima di cantare vittoria. Perché anche negli esercizi passati la blindatura del testo sembrava cosa fatta, salvo successivamente dimostrarsi fragilissima cosa e procrastinare l'iter di qualche altra settimana, proprio a ridosso del panettone. Ricordo, nel 2005, il redattore di un noto quotidiano sostenere con sincera convinzione che "quest'anno la Finanziaria sarà in Gazzetta, al massimo, l'ultima settimana di novembre." Mi ero quasi fidato del suo istinto di vecchio marpione. Salvo poi recuperare il testo ufficiale e vigente a S. Silvestro scappato. Per gli enti locali, tuttavia, la novità strutturale sarebbe un'altra. Parallelamente alla snella legge di bilancio, le norme attinenti in modo specifico gli enti locali (dal patto di stabilità ai trasferimenti erariali) dovrebbero comparire all'interno di un provvedimento 'ad hoc' che ricorda vagamente i vecchi decreti legge sulla finanza locale. E' pur vero che in questi ultimi si raccoglievano talvolta vagonate di norme, valevoli un'intera Finanziaria. Ma il vantaggio starebbe proprio in questo stralcio che si tradurrebbe in una maggiore certezza di obiettivi e nella conseguente chiarezza dei mezzi per raggiungerli. Se, però, come sembrerebbe chiaro dalle notizie che arrivano da Montecitorio, il collegato 'enti locali' (e tutti gli altri collegati, perché non penserete mica che il blocco lobbistico di fine anno rinunci alla sua bella messe di disposizioni...) avrà un percorso istituzionale analogo a quello della norma principale bisogna sperare che il meccanismo, in rodaggio, non si inceppi: per quanto l'esame dei singoli testi possa essere affidato a differenti sottocommissioni, il rischio è a ben vedere l'opposto. Che, poiché al numero complessivo dei collegati non è stato fissato un limite, essi crescano in progressione (aritmetica o geometrica, fate voi). E allora il miraggio del rispetto del termine dicembrino resterà lì, intatto e inattaccabile.
Qualcuno comincia a credere sul serio che quest'anno l'approvazione della Legge Finanziaria sarà drasticamente precoce, talché il termine per la deliberazione consiliare del Bilancio di previsione non sarà prorogato e si saluterà il nuovo anno, per la prima volta dopo tempo immemore, senza bisogno di esercizio provvisorio (o peggio, di gestione provvisoria). Questo convincimento nascerebbe da quanto indicato in una risoluzione della Camera dei deputati che, tra le altre cose, si incentra proprio su questo felice proposito. In sostanza, la manovra dovrebbe giungere a rapida conclusione poiché, oltre a essere costituita da un "numero limitato di articoli omogenei, tutti rigorosamente corrispondenti al loro contenuto tipico, evitando l'inserimento di norme meramente ordinamentali, ovvero di carattere localistico o microsettoriale.", sarà (pare) estremamente difficile per l'esecutivo proporre emendamenti al testo una volta giunto in aula per la votazione. Sul punto della riduzione degli articoli vien da sorridere, pensando a quante leggi di bilancio hanno racchiuso in un unico clamoroso blocco cornucopie di provvedimenti frammentati in centinaia (o migliaia, talvolta) di commi. Se non altro, qui si sostiene che ci dovrà essere omogeneità nel contenuto dei singoli articoli, ma aspetterei prima di cantare vittoria. Perché anche negli esercizi passati la blindatura del testo sembrava cosa fatta, salvo successivamente dimostrarsi fragilissima cosa e procrastinare l'iter di qualche altra settimana, proprio a ridosso del panettone. Ricordo, nel 2005, il redattore di un noto quotidiano sostenere con sincera convinzione che "quest'anno la Finanziaria sarà in Gazzetta, al massimo, l'ultima settimana di novembre." Mi ero quasi fidato del suo istinto di vecchio marpione. Salvo poi recuperare il testo ufficiale e vigente a S. Silvestro scappato. Per gli enti locali, tuttavia, la novità strutturale sarebbe un'altra. Parallelamente alla snella legge di bilancio, le norme attinenti in modo specifico gli enti locali (dal patto di stabilità ai trasferimenti erariali) dovrebbero comparire all'interno di un provvedimento 'ad hoc' che ricorda vagamente i vecchi decreti legge sulla finanza locale. E' pur vero che in questi ultimi si raccoglievano talvolta vagonate di norme, valevoli un'intera Finanziaria. Ma il vantaggio starebbe proprio in questo stralcio che si tradurrebbe in una maggiore certezza di obiettivi e nella conseguente chiarezza dei mezzi per raggiungerli. Se, però, come sembrerebbe chiaro dalle notizie che arrivano da Montecitorio, il collegato 'enti locali' (e tutti gli altri collegati, perché non penserete mica che il blocco lobbistico di fine anno rinunci alla sua bella messe di disposizioni...) avrà un percorso istituzionale analogo a quello della norma principale bisogna sperare che il meccanismo, in rodaggio, non si inceppi: per quanto l'esame dei singoli testi possa essere affidato a differenti sottocommissioni, il rischio è a ben vedere l'opposto. Che, poiché al numero complessivo dei collegati non è stato fissato un limite, essi crescano in progressione (aritmetica o geometrica, fate voi). E allora il miraggio del rispetto del termine dicembrino resterà lì, intatto e inattaccabile.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 17:54 0 commenti
Categorie: Finanziaria 2008
mercoledì 1 agosto 2007
Il miglio verde
 La notizia che è appena stato licenziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un disegno di legge per introdurre, obbligatoriamente e progressivamente, un bilancio ambientale anche nelle amministrazioni pubbliche sembra fatta apposta per alimentare discussioni e polemiche sullo stato dell'arte, nel 2007, dei sistemi contabili utilizzati negli enti locali. L'iniziativa, ambiziosa come poche altre (e riproposta senza successo da qualche legislatura in qua), non si propone certo di attivare in breve tempo un impianto tecnico così complesso. E' previsto, infatti, un congruo periodo di transizione, di due anni al massimo, indispensabile per adeguarsi al nuovo impegno. Il fatto stesso che questo processo evolutivo nel mondo della contabilità pubblica si sia avviato (unilateralmente, certo, poiché non vi è traccia di concertazione con le autonomie locali) depone immediatamente benissimo a favore delle ottime intenzioni dei vertici della Ragioneria statale. Depone però malissimo contro la inveterata abitudine di mettere il carro davanti ai buoi. La contabilità ambientale è di certo un apprezzabile obiettivo strategico; citando il recente DPEF: "la sfida del cambiamento del clima impone anche di riconsiderare gli attuali modelli di contabilità economico-finanziari, affiancandogli sistemi contabili e di bilancio in grado di rilevare l'incidenza sull'ambiente delle politiche pubbliche. In tal senso il governo si impegna ad introdurre un sistema di contabilità e bilancio ambientale nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali che integri gli atti di programmazione economica o-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, allo scopo di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di Governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, assicurando, altresì, il diritto all'informazione ambientale." La sequela di concetti alti non riesce a celare completamente la mia personalissima irritazione per la totale mancanza di chiarezza non sul dove si vuole andare, ma sul dove si è ora, estate 2007, nel percorso verso un sistema condiviso di rilevazioni contabili. Poiché stiamo ancora attendendo i principi minimi ai quali dovrebbero uniformarsi gli enti locali nell'implementare la propria contabilità economica (la Finanziaria 2007 fissava il termine al 30 giugno appena trascorso), rimaniamo sospesi nel limbo di una contabilità finanziaria che tutti sostengono sia obsoleta e qualche abbozzo di contabilità economica, che ciascuno acconcia secondo le proprie esigenze, proprio perché linee guida univoche non ve ne sono. E dovremmo quindi aggiungere la contabilità ambientale? Per accumulazioni successive potremmo giungere, paradossalmente, al più avanzato sistema contabile pubblico mai concepito, ma tutto sulla carta, splendido nella sua completezza, malinconico nella sua inutilità. Qualcuno potrebbe sostenere che in qualche ente pilota la sperimentazione è stata avviata e sta producendo effetti positivi. Ma il punto è appunto questo: un manipolo di comuni ben organizzati si presta a migliorare ulteriormente lo standard della qualità amministrativa. Solo la loro, però. Gli altri, infinitamente più numerosi e (non necessariamente per colpa loro) più 'normali', si vedono arrivare contromano tutti i provvedimenti più innovativi che si possano ideare senza che, prima, qualcuno si impegni a mettere i puntini sulle 'i' dell'esistente. Che pensiero si ha del c.d. 'sistema Paese' se ciascuno marcia alla sua velocità e per i meno efficienti rimane l'obbligo di arrangiarsi a trovare il bandolo di una matassa che nessuno vuole districare.
La notizia che è appena stato licenziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un disegno di legge per introdurre, obbligatoriamente e progressivamente, un bilancio ambientale anche nelle amministrazioni pubbliche sembra fatta apposta per alimentare discussioni e polemiche sullo stato dell'arte, nel 2007, dei sistemi contabili utilizzati negli enti locali. L'iniziativa, ambiziosa come poche altre (e riproposta senza successo da qualche legislatura in qua), non si propone certo di attivare in breve tempo un impianto tecnico così complesso. E' previsto, infatti, un congruo periodo di transizione, di due anni al massimo, indispensabile per adeguarsi al nuovo impegno. Il fatto stesso che questo processo evolutivo nel mondo della contabilità pubblica si sia avviato (unilateralmente, certo, poiché non vi è traccia di concertazione con le autonomie locali) depone immediatamente benissimo a favore delle ottime intenzioni dei vertici della Ragioneria statale. Depone però malissimo contro la inveterata abitudine di mettere il carro davanti ai buoi. La contabilità ambientale è di certo un apprezzabile obiettivo strategico; citando il recente DPEF: "la sfida del cambiamento del clima impone anche di riconsiderare gli attuali modelli di contabilità economico-finanziari, affiancandogli sistemi contabili e di bilancio in grado di rilevare l'incidenza sull'ambiente delle politiche pubbliche. In tal senso il governo si impegna ad introdurre un sistema di contabilità e bilancio ambientale nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali che integri gli atti di programmazione economica o-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, allo scopo di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione di Governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, assicurando, altresì, il diritto all'informazione ambientale." La sequela di concetti alti non riesce a celare completamente la mia personalissima irritazione per la totale mancanza di chiarezza non sul dove si vuole andare, ma sul dove si è ora, estate 2007, nel percorso verso un sistema condiviso di rilevazioni contabili. Poiché stiamo ancora attendendo i principi minimi ai quali dovrebbero uniformarsi gli enti locali nell'implementare la propria contabilità economica (la Finanziaria 2007 fissava il termine al 30 giugno appena trascorso), rimaniamo sospesi nel limbo di una contabilità finanziaria che tutti sostengono sia obsoleta e qualche abbozzo di contabilità economica, che ciascuno acconcia secondo le proprie esigenze, proprio perché linee guida univoche non ve ne sono. E dovremmo quindi aggiungere la contabilità ambientale? Per accumulazioni successive potremmo giungere, paradossalmente, al più avanzato sistema contabile pubblico mai concepito, ma tutto sulla carta, splendido nella sua completezza, malinconico nella sua inutilità. Qualcuno potrebbe sostenere che in qualche ente pilota la sperimentazione è stata avviata e sta producendo effetti positivi. Ma il punto è appunto questo: un manipolo di comuni ben organizzati si presta a migliorare ulteriormente lo standard della qualità amministrativa. Solo la loro, però. Gli altri, infinitamente più numerosi e (non necessariamente per colpa loro) più 'normali', si vedono arrivare contromano tutti i provvedimenti più innovativi che si possano ideare senza che, prima, qualcuno si impegni a mettere i puntini sulle 'i' dell'esistente. Che pensiero si ha del c.d. 'sistema Paese' se ciascuno marcia alla sua velocità e per i meno efficienti rimane l'obbligo di arrangiarsi a trovare il bandolo di una matassa che nessuno vuole districare.
Pubblicato da Massimo Monteverdi alle 18:17 0 commenti
Categorie: Bilancio ambientale, Contabilità economica, Contabilità finanziaria